
29 Set La violenza maschile sulle donne non è una malattia
VIOLENZA MASCHILE. La società è consapevole del significato politico del sessismo e della necessità che entri nella scuola il materiale enorme di saperi e pratiche create dal movimento femminista
Tratto da Il Manifesto
Nelle ultime manifestazioni delle rete Non Una Di meno, impegnata in Italia e nel mondo fin dal 2016 contro la violenza di genere, è comparso lo slogan «Il maschio violento non è malato, è il figlio sano del patriarcato». Il Progetto per la scuola del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara – «Educare alle relazioni» – sembra andare in una direzione opposta. Stando a dichiarazioni riportate dal quotidiano La Stampa del 23 settembre, il compito di affrontare la «cultura machista» e di avviare «una nuova narrazione del maschile e del femminile» dovrebbe essere affidato a un piano nazionale di azioni positive, rivolte a insegnanti e studenti, che il ministero sta mettendo a punto con l’Ordine degli Psicologi, con esplicito riferimento ai gruppi Balint.
Creati originariamente per la formazione dei medici di famiglia, impegnati in relazioni di cura di lunga durata e di particolare intimità e intensità emozionale, ed estesi successivamente ad altre figure professionali, la loro presenza nella scuola non è nuova.
Lo è invece l’iniziativa dell’attuale governo che viene al seguito di casi sempre più frequenti di violenza contro le donne, femminicidi e stupri, riconosciuti finalmente come prodotto di una cultura patriarcale ancora dominante, ma con grande celerità cancellati come tali e ricondotti nell’ambito della patologia e del disagio psichico. La tentazione di medicalizzare fenomeni che appartengono nel loro fondamento alla storia e alla politica -perché tali sono il potere che un sesso ha imposto all’altro e le costruzioni o differenze di genere date come “naturali” – si era già affacciata all’inizio degli anni Settanta con l’istituzione di due corsi di laurea di Psicologia a Roma e a Padova. Riletti, a distanza di 50 anni, gli Atti del convegno indetto dagli studenti a Padova nel marzo del 1973, a cui partecipammo sia io che Luisa Muraro e Elvio Fachinelli, redattori della rivista L’erba voglio, non si sa se disperarsi per la replica cieca di una involuzione che minacciava allora i movimenti non autoritari del ‘68 nella scuola, e oggi le teorie e le pratiche di oltre un secolo di femminismo, oppure sperare che sia una “ripresa” capace oggi di sciogliere gli annodamenti più ambigui tra amore, intimità e violenza.
La prospettiva di consegnare a psicologi, psicoterapeuti e giudici, sottomessi a loro volta all’autorità di un Ordine – per non dire di una corporazione – detentore di un sapere calato dall’esterno, non promette bene per quanto riguarda la libertà di insegnanti e studenti intesa come confronto di esperienze e riflessione su vissuti che la scuola eredita dagli anni della crescita in famiglia. Scriveva già allora Luisa Muraro: «Di una cosa sono certa: è vero che il sapere psicologico è elaborato, trasmesso e usato contro di noi, contro quelli tra noi che non si conformano a modelli sociali, per sistemarci e classificarci a seconda: in ospedale, in manicomio, oppure per recuperarci per la famiglia e la fabbrica; questo riesce e funziona non tanto a partire da certe idee, ma a partire da una divisione tra competenti e incompetenti. È questa divisione che lascia sprovveduti e disarmati di fronte alla decisione sociale di emarginare, di fronte alla interpretazione delle differenze di comportamento come deviazioni pericolose da curare. Io voglio capire quel che mi succede, e quello che succede a quelli che mi sono vicini, questo sapere non può stare in mano ad altri».
Non nego di aver avuto anch’io, nel corso del mio insegnamento in una scuola media inferiore, la tentazione di affidare un alunno particolarmente “difficile” allo psicologo. Poi mi resi conto che avrei ripetuto e confermato in questo modo l’esperienza di abbandono che il ragazzo doveva aver già vissuto in precedenza e che era forse la causa della sua aggressività verso di me e verso gli altri. Restava come soluzione quella di vedere se il suo comportamento era effettivamente così eccezionale come sembrava, o se riproduceva in modo accentuato difficoltà di rapporti comuni a tutti i compagni di classe. Discutendo insieme dei loro rapporti mi resi conto che, via via, i ragazzi stessi fornivano delle spiegazioni, in modo tale che non c’era più il pericolo che il ruolo di chi spiega o interpreta venisse attribuito ad altri. È di quegli stessi anni la nascita di gruppi di autoformazione, aperti e tali da mettere insegnanti e psicologi nella condizione di elaborare un sapere comune. L’idea era di evitare la deresponsabilizzazione che interviene quando si separa il proprio ruolo da quello dello psicologo, visto come depositario di una “competenza” e di un sapere risolutivo. Ora, quello che può accadere, come è capitato con il «Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere», approvato nel 2015 dal Consiglio dei Ministri, è che non se ne faccia nulla. Ma il danno è già nel tentativo di distorcere cambiamenti che sono avvenuti nella società: la consapevolezza del significato politico del sessismo e la necessità che entri nella scuola il materiale enorme di saperi, pratiche create da mezzo secolo di movimento delle donne. La risposta alla crisi e alla messa in discussione dei ruoli, familiari, professionali, per come li abbiamo ereditati, al disorientamento di generazioni senza prospettive di futuro, con l’enfatizzazione di una copertura di ordine e di sicurezza psicologica, che Fachinelli chiamerebbe un «sistema genitoriale accessorio», non può che confermare il dubbio che esistano ancora istituzioni in grado di rappresentare e governare un Paese.
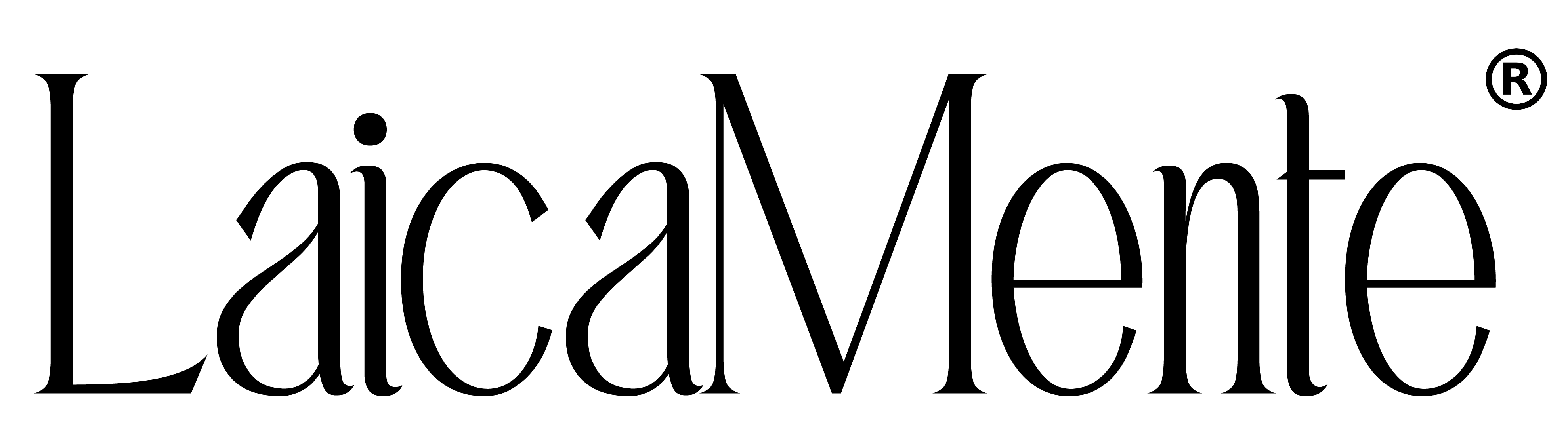

Sorry, the comment form is closed at this time.