
08 Mar Israele sta cadendo nell’abisso
Tratto da nonmollare quindicinale post azionista, articolo di David Grossman
Pubblichiamo come editoriale questa riflessione del grande scrittore israeliano David Grossman sul momento più tragico della storia di Israele e di tutto il Medio Oriente. È apparso sul “New York Times” del primo marzo e lo abbiamo ripreso dalla Rete di Internet perché ci appare il contributo più serio, più addolorato, al di fuori degli opposti fanatismi che stanno arrecando morte e distruzione. È necessario che lo meditino tutti, ma soprattutto i membri della comunità ebraica sparsi ovunque, che dovrebbero assumere un ruolo più attivo di pressione contro l’attuale politica disastrosa della estrema destra israeliana che sta arrecando danni epocali e chissà irreversibili ai rapporti tra ebrei e il resto del mondo. Devono comprendere che la partita in gioco è enorme, e supera persino la questione dei confini di Israele e dei suoi problemi con i Palestinesi. Netanyahu sta compromettendo ben altro: purtroppo il veleno dell’antisemitismo e persino il negazionismo della Shoa corrono il rischio di riprendere fiato e oscurare le responsabilità storiche che abbiamo assunto nel Novecento. Un’ultima osservazione, forse pleonastica per i lettori del “NonMollare”. Nel terzo millennio sono ancora le gerarchie ecclesiastiche dei tre monoteismi ad alimentare le ignoranze più radicate, i fanatismi più pazzi, l’irrazionalità più delittuosa. [e.ma.]
Mentre la mattina del 7 ottobre si allontana, i suoi orrori sembrano solo aumentare. Ancora e ancora, noi israeliani ci raccontiamo ciò che è diventato parte della storia formativa della nostra identità e del nostro destino. Come per diverse ore i terroristi di Hamas abbiano invaso le case degli israeliani, ucciso circa 1.200 persone, stuprato e rapito, saccheggiato e bruciato. Durante quelle ore da incubo, prima che le Forze di Difesa Israeliane si riprendessero dallo shock, gli israeliani hanno avuto un’idea dura e concreta di ciò che potrebbe accadere se il loro Paese non solo subisse un duro colpo, ma cessasse davvero di esistere. Se Israele non fosse più. Ho parlato con persone ebree che vivono fuori da Israele e che mi hanno detto che la loro esistenza fisica – e spirituale – si è sentita vulnerabile in quelle ore. Ma non solo: qualcosa della loro forza vitale era stato preso, per sempre. Alcuni sono stati persino sorpresi dall’entità del bisogno che avevano di Israele, sia come idea che come fatto concreto. Mentre l’esercito iniziava a contrattaccare, la società civile si stava già arruolando in massa nelle operazioni di soccorso e logistiche, con molte migliaia di cittadini che si offrivano volontari per fare ciò che il governo avrebbe dovuto fare se non fosse stato in uno stato di paralisi incosciente.
Al momento della pubblicazione, secondo i dati del Ministero della Sanità di Gaza gestito da Hamas, più di 30.000 palestinesi sono stati uccisi nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre. Tra questi ci sono molti bambini, donne e civili, molti dei quali non erano membri di Hamas e non hanno avuto alcun ruolo nel ciclo della guerra. “Non coinvolti”, come li chiama Israele in conflictese, il linguaggio con cui le nazioni in guerra si ingannano per non affrontare le ripercussioni dei loro atti. Il famoso studioso di cabala Gershom Scholem ha coniato un detto: «Tutto il sangue scorre verso la ferita». Quasi cinque mesi dopo il massacro, Israele si sente così. La paura, lo shock, la furia, il dolore, l’umiliazione e la vendetta, le energie mentali di un’intera nazione – tutto questo non ha smesso di fluire verso quella ferita, verso l’abisso in cui stiamo ancora cadendo. Non possiamo mettere da parte i pensieri delle ragazze e delle donne, e anche degli uomini, a quanto pare, che sono stati violentati dagli aggressori di Gaza, assassini che hanno filmato i loro crimini e li hanno trasmessi in diretta alle famiglie delle vittime; dei bambini uccisi; delle famiglie bruciate vive. E gli ostaggi. Quegli israeliani che da 146 giorni sono tenuti nei tunnel, alcuni forse in gabbia. Sono bambini e anziani, donne e uomini, alcuni dei quali sono malati e forse stanno morendo per l’insufficienza di ossigeno e di medicine e per la mancanza di speranza. O forse stanno morendo perché i normali esseri umani esposti al male assoluto e demoniaco spesso perdono l’innata voglia di vivere, la voglia di vivere in un mondo in cui sono possibili tanta malvagità e crudeltà. In cui vivono persone come i terroristi di Hamas. L’enormità degli eventi del 7 ottobre a volte cancella la nostra memoria di ciò che è venuto prima. Eppure, circa nove mesi prima del massacro, nella società israeliana si stavano manifestando crepe allarmanti.
Il governo, con Benjamin Netanyahu a capo, stava cercando di far passare una serie di provvedimenti legislativi volti a indebolire fortemente l’autorità della Corte Suprema, infliggendo così un colpo mortale al carattere democratico di Israele. Centinaia di migliaia di cittadini sono scesi in piazza ogni settimana, tutti quei mesi fa, per protestare contro il piano del governo. La destra israeliana sosteneva il governo. L’intera nazione stava diventando sempre più polarizzata. Quella che una volta era una legittima discussione ideologica tra destra e sinistra si era evoluta in uno spettacolo di profondo odio tra le varie tribù. Il discorso pubblico era diventato violento e tossico. Si parlava di dividere il Paese in due popoli separati. L’opinione pubblica israeliana sentiva che le fondamenta della sua casa nazionale stavano tremando e rischiavano di crollare. Per coloro che vivono in Paesi in cui il concetto di casa è dato per scontato, devo spiegare che per me, attraverso le mie lenti di israeliano, la parola “casa” significa una sensazione di sicurezza, difesa e appartenenza che avvolge la mente con calore. Casa è un luogo in cui posso esistere con tranquillità. Ed è un luogo i cui confini sono riconosciuti da tutti, in particolare dai miei vicini. Ma tutto questo, per me, è ancora immerso in un desiderio di qualcosa che non è mai stato pienamente raggiunto. Attualmente, temo che Israele sia più una fortezza che una casa. Non offre né sicurezza né agio, e i miei vicini nutrono molti dubbi e richieste sulle sue stanze e sulle sue mura e, in alcuni casi, sulla sua stessa esistenza. In quel terribile sabato nero, è emerso che non solo Israele è ancora lontano dall’essere una casa nel senso pieno del termine, ma non sa nemmeno come essere una vera fortezza. Tuttavia, gli israeliani sono giustamente orgogliosi del modo rapido ed efficiente in cui si radunano per offrire sostegno reciproco quando il Paese è minacciato, sia da una pandemia come la Covid-19 che da una guerra. In tutto il mondo, i soldati della riserva sono saliti sugli aerei per raggiungere i loro compagni già chiamati alle armi. Andavano “a proteggere la nostra casa”, come dicevano spesso nelle interviste. C’era qualcosa di commovente in questa storia unica: questi giovani uomini e donne si sono precipitati al fronte dai confini del mondo per proteggere i loro genitori e nonni. Ed erano pronti a dare la vita. Altrettanto commovente è stato il senso di unità che prevaleva nelle tende dei soldati, dove le opinioni politiche non erano importanti. Tutto ciò che contava era la solidarietà e il cameratismo. Ma gli israeliani della mia generazione, che hanno vissuto molte guerre, si stanno già chiedendo, come facciamo sempre dopo una guerra: perché questa unità emerge solo nei momenti di crisi? Perché solo le minacce e i pericoli ci rendono coesi e fanno emergere il meglio di noi, e ci sottraggono anche alla nostra strana attrazione per l’autodistruzione, per la distruzione della nostra stessa casa? Queste domande provocano un’intuizione dolorosa: la profonda disperazione provata dalla maggior parte degli israeliani dopo il massacro potrebbe essere il risultato della condizione ebraica in cui siamo stati nuovamente gettati. È la condizione di una nazione perseguitata e non protetta. Una nazione che, nonostante i suoi enormi successi in tanti campi, è ancora, nel profondo, una nazione di rifugiati, permeata dalla prospettiva di essere sradicata anche dopo quasi 76 anni di sovranità.
Oggi è più chiaro che mai che dovremo sempre vigilare su questa casa fragile e penetrabile. È stato anche chiarito quanto sia radicato l’odio di questa nazione. Segue un’altra riflessione su questi due popoli martoriati: il trauma di diventare rifugiati è fondamentale e primordiale sia per gli israeliani che per i palestinesi, eppure nessuna delle due parti è in grado di guardare alla tragedia dell’altra con un briciolo di comprensione, per non parlare di compassione. Un altro fenomeno vergognoso è emerso a seguito della guerra: Israele è il Paese al mondo di cui si chiede più apertamente l’eliminazione. Nelle manifestazioni a cui partecipano centinaia di migliaia di persone, nei campus delle università più rispettate, sui social media e nelle moschee di tutto il mondo, il diritto all’esistenza di Israele viene spesso contestato con entusiasmo. Una critica politica ragionevole che tenga conto della complessità della situazione può cedere il passo – quando si tratta di Israele – a una retorica dell’odio che può essere raffreddata (se mai lo sarà) solo dalla distruzione dello Stato di Israele. Per esempio, quando Saddam Hussein uccise migliaia di curdi con armi chimiche, non ci furono appelli a demolire l’Iraq, a cancellarlo dalla faccia della terra. Solo quando si tratta di Israele è accettabile chiedere pubblicamente l’eliminazione di uno Stato. I manifestanti, le voci influenti e i leader pubblici dovrebbero chiedersi cosa c’è in Israele che provoca questo disgusto. Perché Israele, tra i 195 Paesi del pianeta, è il solo a essere condizionato, come se la sua esistenza dipendesse dalla buona volontà delle altre nazioni del mondo? È nauseante pensare che questo odio omicida sia rivolto esclusivamente a un popolo che meno di un secolo fa era stato quasi sradicato. C’è anche qualcosa di irritante nel tortuoso e cinico collegamento tra l’ansia esistenziale degli ebrei e il desiderio espresso pubblicamente da Iran, Hezbollah, Hamas e altri che Israele cessi di esistere. È inoltre intollerabile che alcune parti cerchino di costringere il conflitto israelo-palestinese in un quadro colonialista, quando dimenticano volontariamente e ostinatamente che gli ebrei non hanno un altro Paese, a differenza dei colonialisti europei a cui vengono falsamente paragonati, e oscurano il fatto che gli ebrei non sono arrivati in terra d’Israele per conquistare, ma in cerca di sicurezza; che la loro potente affinità con questa terra ha quasi 4.000 anni; che è qui che sono emersi come nazione, religione, cultura e lingua. Si può immaginare la gioia maliziosa con cui queste persone calpestano il punto più fragile della nazione ebraica, il suo senso di estraneità, la sua solitudine esistenziale – quel punto da cui non ha rifugio. È questo punto che spesso la condanna a commettere errori fatali e distruttivi, distruttivi sia per i suoi nemici che per se stessa. Chi saremo – israeliani e palestinesi – quando questa lunga e crudele guerra avrà fine? Non solo il ricordo delle atrocità inflitte l’uno all’altro ci separerà per molti anni, ma anche, come è chiaro a tutti noi, non appena Hamas ne avrà la possibilità, metterà rapidamente in atto l’obiettivo chiaramente indicato nel suo statuto originale: il dovere religioso di distruggere Israele. Come possiamo quindi firmare un trattato di pace con un tale nemico? Eppure, che scelta abbiamo? I palestinesi faranno i conti da soli.
Come israeliano mi chiedo che tipo di persone saremo quando la guerra finirà. Dove indirizzeremo il nostro senso di colpa – se saremo abbastanza coraggiosi da provarlo – per ciò che abbiamo inflitto a palestinesi innocenti? Per le migliaia di bambini che abbiamo ucciso. Per le famiglie che abbiamo distrutto. E come impareremo, per non essere mai più sorpresi, a vivere una vita piena sul filo del rasoio? Ma quanti vogliono vivere la propria vita e crescere i propri figli sul filo del rasoio? E quale prezzo pagheremo per vivere in costante vigilanza e sospetto, in perenne paura? Chi di noi deciderà che non vuole – o non può – vivere la vita di un eterno soldato, di uno spartano? Chi resterà qui in Israele, e quelli che resteranno saranno i più estremi, i più fanaticamente religiosi, nazionalisti, razzisti? Siamo condannati a guardare, paralizzati, mentre l’audacia, la creatività, l’unicità di Israele viene gradualmente assorbita nella tragica ferita dell’ebraismo? Queste domande probabilmente accompagneranno Israele per anni. Esiste, tuttavia, la possibilità che una realtà radicalmente diversa sorga per contrastarle. Forse il riconoscimento che questa guerra non può essere vinta e, inoltre, che non possiamo sostenere l’occupazione all’infinito, costringerà entrambe le parti ad accettare una soluzione a due Stati che, nonostante i suoi svantaggi e i suoi rischi (primo fra tutti, che Hamas prenda il controllo della Palestina in un’elezione democratica), è ancora l’unica praticabile? Questo è anche il momento per gli Stati che possono esercitare un’influenza sulle due parti di usarla. Non è il momento della politica spicciola e della diplomazia cinica. È un momento raro in cui un’onda d’urto come quella che abbiamo vissuto il 7 ottobre ha il potere di rimodellare la realtà. I Paesi coinvolti nel conflitto non vedono che israeliani e palestinesi non sono più in grado di salvarsi da soli?
I prossimi mesi determineranno il destino di due popoli. Scopriremo se il conflitto che dura da più di un secolo è maturo per una risoluzione ragionevole, morale e umana. È tragico che ciò avvenga – se davvero avverrà – non per speranza ed entusiasmo, ma per stanchezza e disperazione. D’altra parte, questo è lo stato d’animo che spesso porta i nemici a riconciliarsi, e oggi è tutto ciò che possiamo sperare. E quindi ci accontenteremo. Sembra che abbiamo dovuto attraversare l’inferno stesso per arrivare al luogo da cui si può vedere, in una giornata eccezionalmente luminosa, il bordo lontano del cielo.
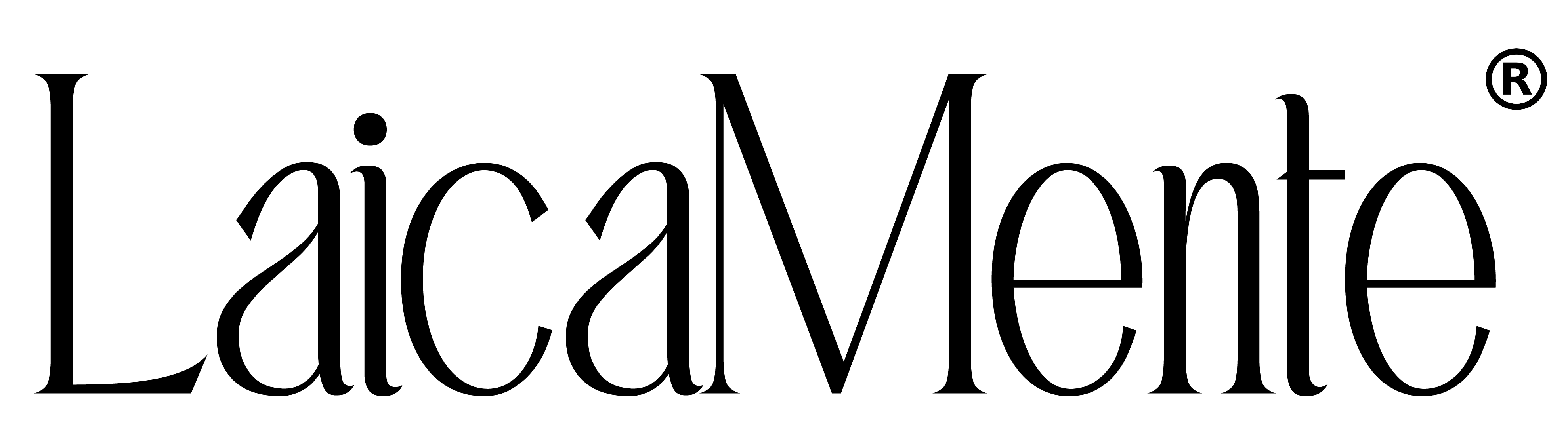

Sorry, the comment form is closed at this time.