
15 Mar Iran, Mahvash Sabet: “Ascoltate il mio grido dal carcere di Evin”
Tratto da La Repubblica, di Mahvash Sabet
Ho fatto in modo di lasciare scritte le mie parole su piccoli pezzi di carta, usciti di volta in volta, frase per frase, dalla cella
Se potete leggere questa lettera è perché, simulando raffreddori e malanni, ho fatto in modo di lasciare scritte le mie parole su piccoli pezzi di carta, usciti di volta in volta, frase per frase, dal terribile carcere di Evin. Come cerco di fare, del resto, con le mie poesie.
Quando è avvenuta la rivoluzione, avevo 26 anni. Ero la direttrice di una scuola di un quartiere povero, a Sud di Teheran. Un giorno mi diedero questa sentenza: “squalificata”, cioè negata, esclusa. Da tutto.
Quel diventare “squalificati” al giudizio del potere significa: “divieto” di lavorare, “divieto” di proseguire gli studi universitari, “divieto” di esercitare ogni diritto civile, persino di avere eventualmente diritto alla sepoltura.
A mio marito fu inflitto lo stesso “divieto”. Mio padre, mio fratello, tutti i miei parenti, amici e compagni di fede, tutti travolti: gradualmente divennero disoccupati e rimasero a casa, e tutte le nostre vite furono esposte a una tempesta. Tutti “rinnegati”.
Centinaia di persone furono imprigionate in tutto il Paese e ogni giorno sentivamo alla radio la notizia dell’esecuzione di alcuni conoscenti e amici. Il 100 per cento dei beni della nostra comunità e le proprietà di molti dei miei correligionari furono confiscati e quasi 250 persone furono giustiziate solo per il reato di essere Bahá’í.
Quando sono stata arrestata nel 2006, ho trascorso due anni e mezzo sotto pressione, con interrogatori condotti in celle di sicurezza anguste e buie; noi, sette membri del gruppo noto come “Yárán-i-Irán”, siamo stati portati in tribunale con una condanna a morte e sotto accusa è stata messa persino la nostra più nobile attività umanitaria, cioè il servizio volontario nell’amministrazione della nostra comunità: condannati a vent’anni di reclusione.
Un giorno, mi sono detta, scriverò tutto e smaschererò l’infondatezza dell’accusa di spionaggio. Dirò alla gente che non abbiamo mai tradito il nostro Paese. Amiamo l’Iran e vogliamo l’onore e l’orgoglio del nostro Paese.
Mi ci sono voluti anni per cambiare le mie abitudini, per abituarmi alla vita nel mondo chiuso e crudele della prigione, spesa sotto le telecamere a circuito chiuso. Una volta uscita dal carcere, dovevo cambiare di nuovo le mie abitudini fisiche e mentali, riadattarmi psicologicamente, e non è stato affatto facile.
Avevo paura di attraversare la strada. Avevo l’ansia nei centri commerciali. La velocità e la congestione delle strade mi davano mal di testa e nausea. Il ritmo del cambiamento mi ha confuso e mi ha reso debole. A volte chiudevo gli occhi per non vedere la folla. Avevo un disturbo di “paura della vita all’aria aperta”! Tutto era cambiato.
E ovunque fossi, ero un’estranea. Metà del mio essere era rimasta in prigione e con i miei compagni di cella. Le sofferenze delle donne nelle carceri di Mashhad, Gohar-dasht, Qarachak ed Evin con cui avevo vissuto, non mi lasciavano andare.
Un giorno, dopo due anni e mezzo, un gruppo di agenti speciali ha fatto irruzione nella nostra casa per l’ennesima volta, distruggendo tutto compreso le nostre vite. Avevano con loro un mandato di comparizione per il mio arresto, presso il tribunale rivoluzionario di Ramsar. L’accusa? «Appartenenza alla religione deviante dei Baha’i».
Dopo l’arresto, ho trascorso 42 giorni in isolamento sotto gli interrogatori più difficili, atroci ed estenuanti, accompagnati da violenze, insulti, minacce e calunnie. Sono stata portata nell’ufficio del procuratore a Evin per la nuova accusa, il capo di imputazione era «setta deviante con l’obiettivo di minacciare la sicurezza del Paese».
Da oggi e fino al giorno del processo, non sono e non sarò autorizzata a conoscere il contenuto della mia causa. Non ho incontrato il mio avvocato davanti al tribunale e non so se un legale abbia letto il mio caso, oppure no. Ma come potrebbe esserci difesa senza incontrare l’imputato? Il giudice ha preso la sua decisione dopo avermi vista nella breve udienza, e mi ha negato ogni diritto.
Dopo cinque mesi (da novembre a oggi), in una fredda giornata invernale, sono stata trasferita nella prigione femminile di Evin, indossando gli abiti con cui ero stata arrestata, abiti estivi di cotone. Il mio corpo era esausto e le mie ginocchia erano doloranti e gonfie per essere stata sbattuta contro il muro nella stanza degli interrogatori.
Sono tornata al carcere femminile di Evin, dove meno di cinque anni prima, dopo aver sopportato dieci anni di reclusione, avevo baciato la sua terra davanti alle mie compagne di Fede e prigioniere politiche e avevo lasciato quel luogo.
Ricordo che, anni fa, quando dissi al giudice che un giorno saremmo usciti da questa prigione, lui rispose con calma: «Ma decideremo noi se sarà orizzontale o verticale!».
Ora non vedo più un orizzonte davanti a me e ho perso la speranza. Il governo del nostro Paese ci ha “squalificati a vita”, ma per favore non lo fate voi. Per favore, non abbandonateci! Ascoltate le nostre storie dalle nostre stesse parole. Per noi Bahá’i «il mondo è un paese e l’umanità i suoi cittadini», e solo per questo veniamo considerati traditori di patria!
Mahvash Sabet, poetessa iraniana in carcere
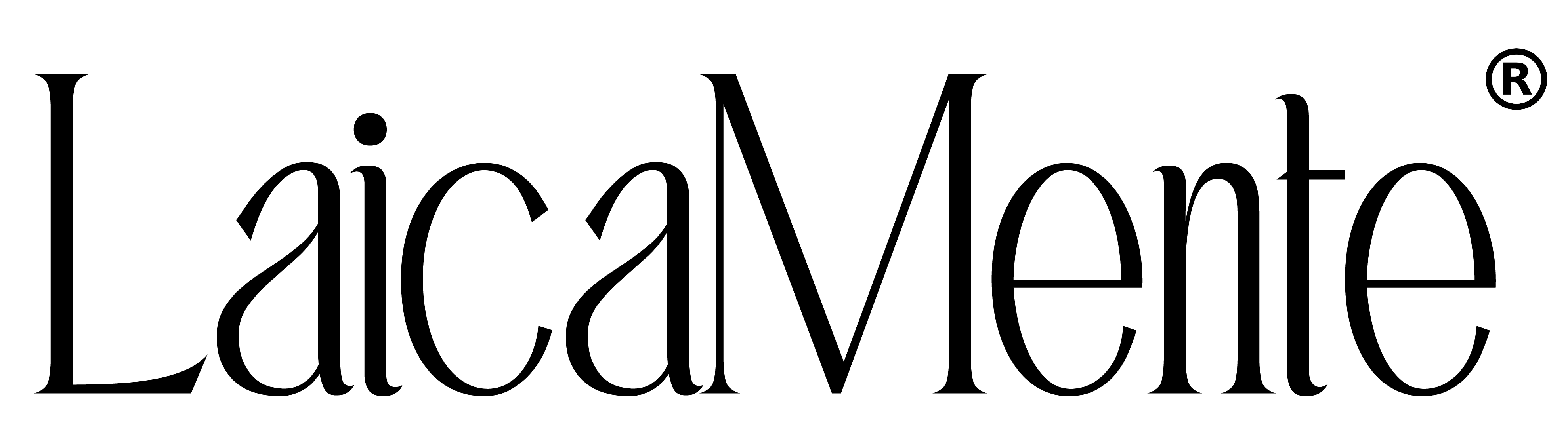

Sorry, the comment form is closed at this time.