
26 Gen Per essere felici bisogna essere pessimisti (forse)
Online, vi sarà capitato di imbattervi in consulenti, guru e motivatori vari; urlano, imboniscono, seducono ma, a dirla tutta, avviliscono anche un po’. Basta con questo ottimismo falso, la vita non ha senso! Deprimente? Tutt’altro. Lo dice anche Proust.
Tratto da Lucy, articolo di Antonio Pascale
Nei momenti di apatia, di spleen, di distrazione, quando la gravità ti consegna la piacevole e insieme disdicevole sensazione che mai più ti alzerai dal divano, allora, imbambolato da forze maggiori, scorrendo i reel dei social, per via della magia inquietante degli algoritmi, ecco che ti appaiono a ripetizione i video dei motivatori, un contrappasso dantesco al contrario: sei sdraiato, allora devi alzarti.
Sono centinaia, e scorro le piattaforme con indolenza e di ognuno conservo alcune massime che prima mi sembrano luminose poi si affievoliscono e allora passo alla successiva (pillole motivatori: dedicato agli artisti della propria vita; potenziale mentale: dobbiamo essere la migliore versione di quello che possiamo essere; motivazione persone: alzati, vai ad affrontare la vita reale e se il mondo è un bastardo allora colpiscilo con tutta la forza che hai) imprenditori di successo, noti e molto meno noti, quelli del Bitcoin e quelle di OF o viceversa (il diario di un imprenditore: oggi diventare ricchi è più facile che mai), psicologi di risme varie (neural code: ricorda: la cosa più importante al mondo è ciò che credi di te stesso) e non solo: pazienti che siccome sono in un percorso di analisi, probabilmente ancora soggiogati dal transfert, ti spiegano come fare a vivere meglio o a uscire da una relazione tossica, il tutto in poche mosse (in genere tre o cinque). Seguono i preparatori atletici che ti svelano i trucchi per perdere peso, gli ex obesi che a loro volta ti spiegano trucchi per gli addominali, per tutte le fasce muscolari e di età (mindset TikTok: lasciati indietro la normalità; musclemindset: continua ad avanzare finché non ce la fai più, mi fai sapè? Bene, vai!) Nel conteggio vanno inseriti i mistici che ti raccontano come preparare il tuo corpo astrale all’aldilà, come parlare con i defunti, come vivere in armonia con le solite vibrazioni che permeano tutto il cosmo e che devi imparare ad accogliere, quelli che ti dicono come risultare attraenti in tre mosse (Matteo Cavenaghi: ti aiuto a cambiare prospettiva sulla tua vita).
I motivatori sono capaci di buttarmi in uno stato di profonda prostrazione.
Una rapida rubricazione evidenzia inoltre due categorie: quelli che gridano e quelli che parlano con voce soave. Confesso di preferire quelli che gridano: sono le sei e ancora dormi? Devi alzarti, darti da fare, approfittare della mattina per correre, fare esercizi mentali, i ricchi non dormono – dicono. Sì, preferisco loro, quelli col megafono, almeno esprimono a tinte forti l’essenza del motivatore: la convinzione ottimistica che la vita la gestisci tutta tu, che la volontà è potere. Convinzione che sembra cool, in perfetta aderenza con la spirito dei tempi, in armonia con le forme narrative ricorrenti dei tre atti (pensa ai tuoi sbagli, convertiti e vedrai la luce), una speranza ridondante che forse ti sostiene in alcuni momenti bui ma ha uno spiacevole lato oscuro: se poi fallisci, se la tua volontà non ti porta ad avere potere, allora la colpa è solo tua. L’ottimismo è come il concetto di cura, così Weltanschauung, che ogni volta che citi Battiato scatta l’applauso: l’ottimismo prevede sempre un motivatore che conosce le leggi del volo, che tesse i tuoi capelli come trame di un canto e che ti ripete ogni mattina: tu sei un essere speciale avrò cura di te.
Un amore incondizionato, falso e bislacco, quasi sempre ricattatorio e sempre col sorriso sulle labbra che alla fin fine, nel lungo periodo, altro non fa che creare un sistema di potere dove c’è chi cura (il motivatore ottimista) e chi è curato (il depresso spaesato). Chi cura detiene le regole, i comandamenti, conosce la vita ed è pronto a insegnartela. Chi è curato non ha altra scelta che seguire le regole, pena l’abbandono e un pesantissimo aggravio per via del senso di colpa, eh sì, per non avercela fatta: a fare i soldi, a conquistare il potere, a sentirsi speciale, a comunicare con i defunti, a sintonizzarsi con energie e vibrazioni varie.
“I motivatori sono capaci di buttarmi in uno stato di profonda prostrazione”.
Naturalmente la cura e l’ottimismo presuppongono un senso di onnipotenza fastidiosissimo, arroganza che altro che hybris e ovviamente pure una narrazione retorica di sostegno che vede nel vincente il faro, mentre parla del fallito solo in termini di redenzione. Come nelle peggiori religioni reazionarie, come quei cattolici che papale papale ti dicono che la Chiesa non deve includere, deve convertire, dunque, faccio per dire se sei omossessuale sei accolto sì, ma solo se riconosci la tua colpa: così accade con i motivatori e tutto il floating dell’ottimismo: i motivatori sono preti laici, figli di un catechismo fatto male (che già quando è fatto bene è disturbante…).
Poi vero, gli ottimisti sono molto forti nella speranza e di questo a volte li ringraziamo. Tuttavia, concepiscono la speranza in modo stereotipato, la speranza mia deve essere uguale alla tua, così come la mia felicità assomiglia a quella di tutti: una malsana idea di giustizia spirituale. L’ottimista è un solipsistico fanatico del cambiamento, se lo racconta da solo, ovvio, e disconosce sempre i due Dei che governano la nostra vita, il Tempo e il Caos, una disdicevole mancanza che induce l’ottimista a concentrarsi in maniera convenzionale solo su sé stesso – e ignorare quello che anche i Matia Bazar spiegavano bene e già dal 1979: c’è tutto un mondo intorno che gira ogni giorno e che fermare non potrai.
I motivatori ottimisti sono tragici figli dei romantici; in accordo con certe bislacche teorie, credono che lo scopo della vita sia cercare l’io autentico. Dovrebbe stare nascosto da qualche parte – e non si capisce perché l’io autentico è in catene e pure nascosto, mentre quello che si vede è libero e inautentico. Loro credono che l’io autentico sia un luogo stracolmo di valori. Perché? Perché con le loro storie di self-help in tre atti ti inducono a credere che c’è un bambino mortificato dentro di te, non resta altro che nutrirlo e farlo crescere: cioè essere un monomaniaco, io valgo, io sono eccetera. Presi come sono dalla frenesia del cambiamento, i motivatori ottimisti non accettano l’idea che la nostra mente sia piatta e non così misteriosa né profonda: un algoritmo tra i tanti che processa le informazioni deliberando (e spesso sbagliando) quello che conviene fare da quello che non conviene fare. Ma i motivatori ottimisti non credono nella convenienza, sono alla ricerca di più alti e accesi ideali, sono indefessi sostenitori del libero arbitrio senza se e senza ma. Dunque, tirando le leve giuste, sarai nel posto giusto: e questo vale per la politica, per le scalate in società, per la tua felicità. Che presunzione eh, che senso di onnipotenza, pensare che sei tu che fai la storia e le due suddette divinità vere, reali, non esistono o sono controllabili grazie ai consigli del motivatore di turno. Una presunzione che non porta niente di buono, se non alimentare la speranza e mortificare la consolazione.
Questa è la ragione per cui i fanatici dell’ottimismo e i motivatori onnipresenti finiscono per convertire i più alla causa del pessimismo; del resto quando tutto questo ottimismo ti casca pesantemente addosso, non hai altra speranza che sventolare (gridando) la bandiera del pessimismo. Che va bene, ammetto, il pessimismo è scarso nella speranza però è fortissimo nella consolazione. Inoltre, il pessimismo è una dimensione molto utile e proficua, nonché strumento di indagine privilegiato e non fanfarone. Il pessimismo illustra bene la natura umana, altro che io interiore e sveglia mattutina per andare a correre. Il pessimismo è un onesto strumento di osservazione capace di indicarci la materia di cui sono fatti i nostri sogni (perché, infatti, i nostri sogni dovrebbero essere migliori di noi?).
Il fatto è che questa nostra materia di cui cianciamo invano, è segnata da una ferita, da una crepa: la vita non ha senso ed è questa la vera scoperta che riguarda l’interiorità, la ferita. Non è la mia o la tua ferita o del motivatore di turno. Riguarda tutti. La prima donna o il primo uomo che nel Paleolitico avrà alzato gli occhi al cielo con un barlume di coscienza avrà pensato: che ci faccio qua? È un’angoscia primordiale, è la nostra ferita atavica e inguaribile. Ecco, il pessimista ha visto la ferita (nei casi migliori, l’ha anche saputo accettare).
La differenza tra ottimisti e pessimisti è una sola: come reagiamo alla ferita. L’ha spiegato il filosofo norvegese, Peter Wessel Zapffe con un imperdibile breve saggio scritto negli anni Trenta, L’ultimo Messia. Quando sentiamo la ferita e la conseguente angoscia che sale diciamo va bene, ma in fondo ho una famiglia, una comunità, una patria, cioè cerchiamo un ancoraggio, qualcosa di sicuro con i confini ben definiti che mi tenga al riparo dagli intrusi (su quanto la comunità, con la scusa di ripararti dalla ferita, possa essere violenta poi quello è un altro discorso). Oppure ci si distrae: in fondo il Napoli l’anno scorso ha vinto lo scudetto ma a me che mi frega dell’angoscia? Oppure si isolano questi pensieri cupi: lasciali marcire in qualche angolo del tuo io interiore, almeno l’io interiore serve a qualcosa, lasciali a Giacomino nostro, lasciali a quell’intrattabile di Arturo: tu non ne fare menzione, anche perché poi la gente ti vede come un inguaribile pessimista senza speranza. O infine, sublimiamo il tutto, cioè attraverso l’arte trasformiamo l’angoscia in dolore, perché l’angoscia non la puoi condividere, il dolore sì. I pessimismi lo sanno: non si può guarire, si può raccontare questa convalescenza che è la vita. E migliorare? Forse no, sicuro non seguendo i soliti consigli nelle solite forme narrative del motivatore di turno. E allora? Ci basiamo solo sulla consolazione? E la necessaria luce?
“Il fatto è che questa nostra materia di cui cianciamo invano, è segnata da una ferita, da una crepa: la vita non ha senso ed è questa la vera scoperta che riguarda l’interiorità, la ferita”.
Ma no, aspettate, anche il pessimista irradia luce. Anzi, meglio dell’ottimista è in possesso di alcuni strumenti per illuminare la natura umana. Il pessimista in fondo parla solo delle cose umane. Il pessimista sa che le cose umane si fondano sulla ferita e la ferita a sua volta si declina su quattro pilastri: sintomi, quelli che ci avvisano della ferita e ci rendono fragili (vomito, diarrea, febbre e dolori psicosomatici), trade off (la nostra stessa postura eretta si regge su un compromesso, mani libere ma mal di schiena, senso dell’avventura ma canale del parto piccolo, dunque mortalità delle donne e neonato con cervello piccolo che non sa far niente e necessita di cure), mismatch (siano dissonanti, l’ambiente cambia velocemente, noi no) e infine abbiamo dei precursori naturali, una serie di istinti, abitudini dure a morire che spesso sono un barriera all’azione. Se non consideriamo questi quattro pilastri poi finisce che ci affidiamo al motivatore di turno che ci abitua alla classica forma narrativa, ascesa, declino, redenzione e luce: c’è un bambino dentro di te nutrilo e quello cresce (che poi potrebbe essere anche: c’è un bambino dentro di te ma attento a nutrirlo che diventa un adulto stronzissimo).
Tutto questo solo per occultare la spiacevole sensazione che ci angoscia: la vita non ha senso. Che disperazione, direte voi. No, all’opposto: che incredibile potenzialità di conoscenza, una inquietudine fuori dagli schemi, la grande occasione per non mancare la vita. Ora, per fornire un esempio delle potenzialità del pessimismo, è utile riassumere quello che Marcel Proust diceva sul senso della vita. In fondo la sua opera, più di quattromila pagine, centinaia e centinaia di personaggi, una cattedrale (la definiva lui stesso) la cui magnificenza puoi cogliere con un solo sguardo o puoi imparare a guardare con più attenzione, insomma la Recherche, si avvolge intorno alla domanda: quali sono le ragioni che rendono la vita degna di essere vissuta?
Proust esamina tre possibilità. La prima: vale la pena vivere per avere successo in società, per conoscere le celebrities. La ricerca del tempo perduto anche di questo racconta: di Marcel che si imbuca alle feste, di Marcel che descrive con stupore questo mondo fatato, lussuoso, raffinato, elegante. Un mondo regale che, secondo Proust, affondava le radici in un lontanissimo quanto nobile passato francese, dunque donava stabilità e, con esso, senso alla vita. Ma le celebrities sono un inganno, conti e contesse, marchesi e marchese, gli altolocati del tempo altro non sono che persone comuni, spesso orribili, cattive, ciniche, pettegole. No, le celebrities non rappresentano di certo il senso della vita. Marcel si era illuso, ma poi la disillusione si è messa in moto e ha svelato un’altra strada. La disillusione è la sola forma di conoscenza che Proust ritiene giusto usare. Purtroppo, questa bistrattata forma di conoscenza che perlomeno ci fornisce la distanza tra i nostri sogni e la realtà, viene rubricata ai giorni nostri sotto la voce petulanza: anche perché non ci fa fare gli esercizi la mattina.
Allora? Il senso della vita? L’amore, dai. Gli affidiamo le nostre vite. Marcel Proust è lo scrittore che più di ogni altro ha esaminato la questione amore. E la risposta è secca. No, l’amore non è il senso della vita. Anzi, l’amore ha delle dinamiche che lo fanno assomigliare a una malattia. Tanto è vero che Proust si avvicina al tema dell’amore come un dottore si avvicina al paziente – e qui c’è la sua grande originalità.
Il saggista francese Bernard de Fallois sintetizza così la poetica di Proust sull’amore: “Come si contrae il male? È possibile essere vaccinati? Quanto tempo dura l’incubazione? Quali sono i primi sintomi? Che si può fare quanto appaiono e perché la maggior parte dei malati non si avvede dei sintomi? Quanto tempo il morbo, cioè l’amore, impiega per diffondersi in tutto il corpo? La guarigione è possibile, le ricadute sono frequenti”. Esaminando il morbo come un medico, Proust arriva a definire i quattro momenti che compongono la legge dell’amore: abitudine, ansia, gelosia, oblio. Sono quattro momenti fondativi, eppure non ne parliamo mai, per questo è necessario, utile, nonché esperienza commovente, tenera e affascinante leggere La Recherche – o, se non aveste tempo e voglia, Franco Califano potrebbe fornirvi le stesse riflessioni.
Tutti i personaggi de La Recherche si muovono seguendo questi momenti. Il più noto è Swann, mercante d’arte, affascinante, colto, con un’unica occupazione conosciuta: donnaiolo. Un uomo fatto di desiderio. Ma guardate la descrizione di quella che poi diventerà sua moglie, Odette: “non priva di bellezza, ma di un genere di bellezza che gli era indifferente, che non ispirava nessun desiderio, gli causava perfino una certa repulsione”. Swann incontra Odette nei consueti ricevimenti e fra di loro si forma una dolce abitudine. Fase importante, non è il desiderio che muove l’amore, è l’abitudine, una forza possente ma ambigua: è dolce ma crea dei legami di cui col tempo non possiamo fare a meno. Ma un giorno, per uno stupido inconveniente, Swann arriva in ritardo al ricevimento e Odette non c’è. Dov’è? È il primo sintomo del male, il morbo è arrivato. L’abitudine si è spezzata e sta subentrando l’ansia. È il classico bisogno ansioso che caratterizza l’amore e i lettori de La Recerche (che per fortuna non ascoltano i motivatori) hanno da subito imparato a conoscere. Si declina in tanti modi, è un bisogno ansioso anche quello del piccolo Marcel che aspetta il bacio della madre e la madre tarda ad arrivare, anche i nostri bisogni sono ansiosi.
“Marcel Proust è lo scrittore che più di ogni altro ha esaminato la questione amore. E la risposta è secca. No, l’amore non è il senso della vita. Anzi, l’amore ha delle dinamiche che lo fanno assomigliare a una malattia”.
L’amore che tutto move qui è tradotto come il bisogno ansioso che tutto move. Infatti, Swann si darà da fare e rincontrerà Odette e proverà una incredibile sensazione di sollievo. Quel sollievo è così dolce che si prolungherà per tanto tempo, sera dopo sera, e alla fine procura quel piacere che chiamiamo amore. Ma è solo il morbo che si fa strada, nascondendo i suoi intenti. Poco dopo, infatti, l’amore che Swann proverà verso Odette lo farà sentire male. Accade quando Odette gli dice che stasera no, non ha voglia che Swann resti con lei. Allora il malato entrerà in una nuova devastante fase: la gelosia. La gelosia attiva il sospetto e con i sospetti gli interrogatori e con questi le menzogne.
“L’amore di Swann, cioè la malattia, si era talmente moltiplicata, si era così strettamente mischiato a tutte le abitudini di Swann, a tutte le sue azioni, ai pensieri, alla salute, al sonno, alla sua vita, persino a ciò che desiderava dopo la morte, faceva ormai talmente tutt’uno con Swann che non si sarebbe potuto estirparglielo senza distruggere più o meno del tutto lui medesimo: come si dice in chirurgia, il suo amore non è più operabile”. La gelosia è il centro di tutta l’opera di Proust e credo lo sia, più o meno velata, in tutta la nostra stessa concezione dell’amore; se soffriamo è perché ci sentiamo abbandonati, non considerati, preferiti ad altri, una sofferenza corporale, devastante, che tutti purtroppo abbiamo provato e causato.
Cosa succede dopo questa fase? Nei casi migliori subentra l’oblio, significa che ci rassegniamo all’assenza dell’amato, un’altra abitudine, secondo Proust e secondo Swann, un’abitudine così potente, ancora più potente della gelosia che scatena l’oblio: siamo guariti? Forse sì, o forse siamo pronti a ricominciare seguendo la vecchia e stabile legge dell’amore. L’oblio ha una conseguenza: inficia il senso dell’amore. Pensavamo che quella persona era il nostro centro vitale e invece non è più nulla. Ma se è nulla, allora noi in quel periodo chi siamo stati? Chi era il nostro io dei 20 anni, afflitto dal morbo? Se incontrassimo quell’io malato lo riconosceremmo? Lo compatiremmo? O forse l’abbiamo dimenticato per sempre? Conclusione, per Proust l’amore non è una delle ragioni che rende la vita degna di essere vissuta. L’amore può solo farci prendere confidenza con la nostra mortalità, non è poco ma non è sufficiente.
E allora, escluse le celebrities e l’amore, cosa resta per non dare spazio ai motivatori da strapazzo? Resta l’arte, secondo Proust è il senso della vita. Proust amava gli artisti, perché riuscivano a farci percepire la mortalità e con essa, di conseguenza, una certa attenzione allo scorrere del tempo e della vita. Allora, questo senso della vita? La ricerca del tempo perduto, appunto, la costruzione di un’arca di Noè, nella quale riponiamo tutte le nostre esperienze e su di esse – illuminati dalla luce dell’arte che illude e disillude – riflettiamo sul senso della nostra vita: una visione pessimista ma molto molto sensata sulla natura umana.
Comunque, se proprio ci tenete, fate gli esercizi la mattina, fateli: male non fanno. Io per esempio non me ne perdo uno dei consigli dei motivatori e con fiducia completo i miei circuiti, ma mentre flettete i muscoli, in attesa che il giorno vi porti quel briciolo di luce che vi restituisca momentaneamente lo splendore, non lasciatevi scoraggiare dal pessimismo e nemmeno incoraggiare dagli ottimisti: alleniamoci invece a maneggiare il senso di finitudine, l’unica dimensione che, eliminando il senso del possesso, per contrasto può farci provare un godimento estatico ed etico. La finitudine sì che si fa sentire anche la solitudine. Che poi alcuni – come diceva Leo Ferrè – la chiamano disperazione ma noi, per il momento, stanchi e affannati, considerato questa vita insensata e problematica, la chiameremo invece felicità.
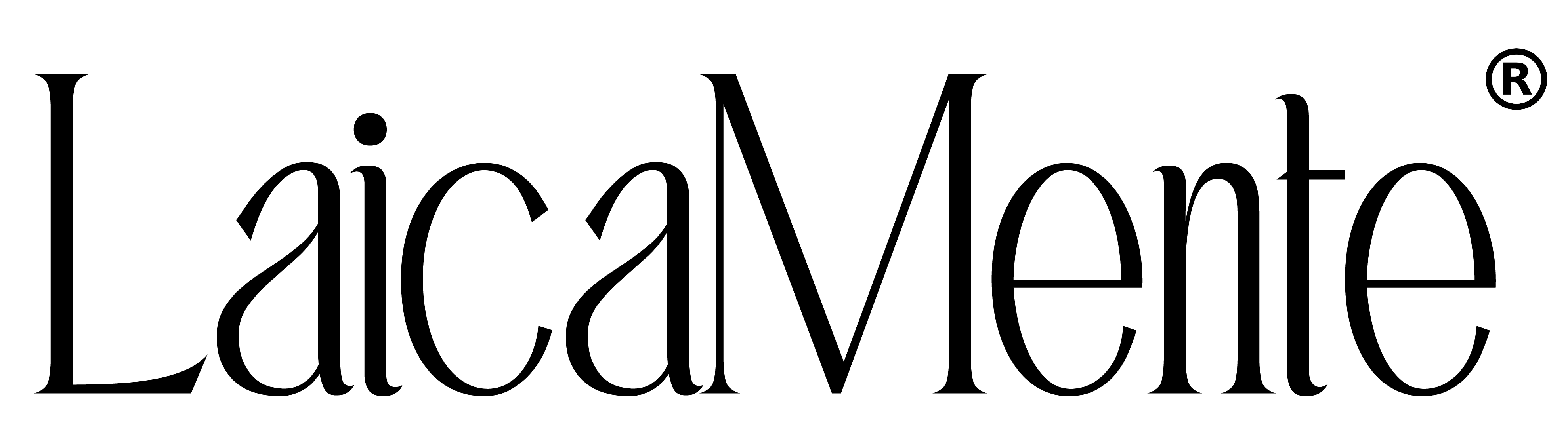

Sorry, the comment form is closed at this time.