
22 Dic Nella mente del terrorista
I recenti attentati di Parigi e Bruxelles ci pongono di fronte a una questione delicata: che legame c’è tra terrorismo e salute mentale? La risposta non è semplice. Per cercarla, dobbiamo prima chiederci con quali pregiudizi guardiamo alla malattia e quanto, nelle nostre società, investiamo davvero nelle politiche per il benessere psicologico.
Tratto da Lucy sulla cultura, articolo di Jessica M. Masucci
Perché diciannove e non venti, cifra tonda? Cinque terroristi sul volo American Airlines 11, cinque sullo United Airlines 175, cinque sull’American Airlines 77 ma solo quattro sullo United Airlines 93. La ricerca di una soluzione a questo enigma aritmetico è la storia della caccia al fantasma del ventesimo attentatore dell’11 settembre 2001. È lungo questa traccia che incrociamo Mohammad Mani Ahmad Al-Qahtani, ex detenuto numero 63 della prigione di Guantanamo.
Il 4 agosto 2001 il cittadino saudita Al-Qahtani prova a entrare negli Stati Uniti dall’aeroporto di Orlando ma gli agenti dell’Immigration and Naturalization Service respingono la sua richiesta, trovando le circostanze del suo viaggio sospette.
Emergerà, poi, che nel parcheggio dell’aeroporto Al-Qahtani avrebbe dovuto incontrare Mohamed Atta, uno dei leader del commando terroristico che ha colpito il World Trade Center e il Pentagono. Della conversazione mai avvenuta tra Atta e Al-Qahtani non sapremo quali sarebbero state le domande del primo e quali le risposte – e le conseguenti azioni – del secondo. Sarebbe, infine, salito su quell’aereo? Un documento desecretato di Guantanamo, risalente al 2017, afferma che l’allora detenuto 63 “probabilmente aveva compreso che sarebbe stato utilizzato in un’operazione suicida, ma era probabilmente all’oscuro dei dettagli dell’attacco”.
Al-Qahtani arriva a Guantanamo nel febbraio 2002, dopo la cattura in Afghanistan, e lascia la prigione nel marzo 2022, destinato a un centro di deradicalizzazione in Arabia Saudita. Qui, secondo l’auspicio del Periodic Review Board, la commissione che decide sul trasferimento o il rilascio dei detenuti di Guantanamo, riceverà le necessarie cure per la sua “significativamente compromessa salute mentale”. L’ex detenuto numero 63 è stato torturato, ma non è solo questo: aveva ricevuto una diagnosi di schizofrenia già da prima della detenzione, della cattura e dell’appuntamento fatale e mancato con Atta. Difficile stabilire se Al-Qaeda ne fosse a conoscenza e come considerasse tale elemento nella sua valutazione del soggetto.
“Non è un tema semplice. Il terrorismo è un concetto non privo di ambiguità, mutevole. Una definizione di salute mentale – formulata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità – ci sarebbe pure ma tra ciò che definiamo salute e malattia esiste un continuum e la soglia tra uno stato e l’altro è spesso impercettibile, difficile da misurare”.
Nello spettro che va dalla presunta sanità a presunti disturbi, gli attentati dell’11 settembre hanno decisamente spostato la percezione che l’opinione pubblica ha dello stato mentale dei terroristi verso la prima. C’entrano le dimensioni e la complessità degli attacchi e dell’organizzazione terroristica. Ma più che sull’idea che abbiamo dei terroristi, questo ci dovrebbe dire qualcosa sui pregiudizi che nutriamo nei confronti del disturbo mentale e che solo oggi, con l’emersione del tema nel discorso pubblico anche in Italia, si stanno incrinando. Sebbene lentamente, sebbene in modo diseguale a seconda delle fasce sociali e anche del tipo di disturbo.
Negli ultimi anni i ripetuti attentati compiuti in Europa da terroristi solitari e l’accresciuto interesse del pubblico nei confronti della salute mentale stanno rendendo molto attuali le domande sul legame tra terrorismo e disturbo psicologico o psichiatrico. La sera del 2 dicembre scorso a Parigi un uomo legato all’Islam radicale ha ucciso un passante e ne ha feriti altri due. Quasi immediatamente è stato reso noto che l’attentatore aveva dei problemi psichiatrici, e questo elemento si è inserito anche nel dibattito politico sull’accaduto.
Non è un tema semplice: immaginate di scattare la foto di un soggetto in movimento con un obiettivo che cambia continuamente lunghezza focale. Il terrorismo è un concetto non privo di ambiguità, mutevole, difficile da fissare in una definizione univoca, che comprende fenomeni anche molto diversi tra loro, per ispirazione ideologica e obiettivi. Vanno poi presi in considerazione anche fattori di contesto: chi per qualcuno è terrorista, per altri può essere considerato, più o meno legittimamente, impegnato in una lotta di liberazione. Insomma, non è semplice. Una definizione di salute mentale – formulata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità – ci sarebbe pure ma tra ciò che definiamo salute e malattia esiste un continuum e la soglia tra uno stato e l’altro è spesso impercettibile, difficile da misurare.
La domanda da cui partire, allora, è: perché i terroristi diventano terroristi? “Ho studiato e ho incontrato persone radicalizzate da tanto tempo e la cosa che mi sorprende è che non c’è mai una singola storia, c’è sempre un ragionamento diverso in ogni caso e cambia da persona a persona”, risponde Raffaello Pantucci, ricercatore senior del Royal United Services Institute (RUSI) di Londra, che per la BBC ha realizzato un podcast dal titolo Terrorism and the Mind. “C’è un concetto, un’idea politica che li spinge; però quando guardi all’individuo ci sono sempre delle ragioni personali, che vanno da ‘io sono arrabbiato con il mondo e voglio esprimerlo in qualche modo’ a ‘la mia vita non sta andando nella direzione che mi aspettavo e ho bisogno di farne qualcosa’”, aggiunge Pantucci.
In una revisione sistematica di articoli scientifici sul nesso tra salute mentale e violenza estremista si citano due principi, equifinalità e multifinalità: percorsi diversi tra loro possono portare alla violenza estremista, e allo stesso tempo persone che partono dalla stessa condizione non diventano tutte estremiste. In altre parole, un profilo universale del terrorista non esiste, ma c’è sempre un insieme di fattori. E allo stesso tempo un singolo fattore, per esempio l’essere esposti alla guerra, non produce effetti uguali in tutte le persone che lo sperimentano. Qualcuno può ripudiare la violenza, altri abbracciarla.

Così come nel tempo si è evoluta la percezione dell’opinione pubblica, negli ultimi vent’anni anche chi fa ricerca sul nesso tra terrorismo e salute mentale ha assistito a dei cambiamenti. Nonostante dopo l’11 settembre si sia prodotta una gran mole di ricerca sul terrorismo, la correlazione tra i due elementi non era supportata dai dati. Parallelamente al declino avvenuto in Europa delle azioni terroristiche portate avanti da gruppi organizzati – prima Al-Qaeda, le cellule dell’ISIS – e all’aumento di attacchi perpetrati da singoli individui radicalizzati, i metodi d’analisi sono migliorati. “Questi individui presentavano più problemi mentali di quanto ci aspettassimo”, spiega la criminologa Emily Corner, che insegna alla Australian National University.
Le ricerche più recenti hanno portato a una prima distinzione fondamentale tra i cosiddetti “lupi solitari” e i terroristi che agiscono in gruppo. Qualunque sia l’orientamento ideologico, tra i terroristi solitari c’è una incidenza di problemi di salute mentale maggiore rispetto alla popolazione generale, mentre nei gruppi la possibilità che ci sia qualcuno con questo tipo di disturbi è la stessa. In una cellula terroristica così come in un’aula di università esiste la probabilità che una persona su quattro abbia problemi psicologici o psichiatrici, ed è anche il motivo per il quale nell’epoca “post 11 settembre” le ricerche mostravano una correlazione debole tra terrorismo e disturbi mentali: erano incentrate su terroristi che avevano agito in gruppo. Lo stesso risultato, spiega Corner, si ottiene comparando i livelli di salute mentale dei criminali comuni che agiscono da soli e chi invece fa parte di gruppi organizzati, per esempio i componenti di una gang.
Una delle spiegazioni più plausibili è che i gruppi organizzati tendano a escludere persone con manifesti problemi psichici perché non le ritengono affidabili per la buona riuscita delle operazioni. Pantucci ricorda di un collega che aveva parlato con un reclutatore di un gruppo armato coinvolto nei “Troubles” in Nord Irlanda, il quale aveva confermato che li evitavano per questo motivo. E che dire di Al-Qahtani? La risposta di Pantucci è che anche le organizzazioni terroristiche sanno essere pragmatiche: aveva un visto per gli Stati Uniti, perché non sfruttarlo? Non è detto che sarebbe stato lui il ventesimo attentatore – posto che ne avessero previsto uno – magari gli volevano solo assegnare un ruolo secondario. Soprattutto, non sappiamo se la schizofrenia di cui soffriva anche allora Al-Qahtani avrebbe avuto rilevanza al momento di scegliere se accettare o meno la proposta di Atta, qualunque essa sarebbe stata.
La domanda principale che si sta ponendo adesso chi fa ricerca è, infatti, se la presenza di disturbi mentali sia rilevante per il comportamento dei terroristi, soprattutto quelli che agiscono da soli. La presenza di disturbi mentali nei “lupi solitari” non interessa solo gli accademici. Nel rapporto 2023 dell’Europol viene ribadita l’aspettativa che la maggior parte degli attacchi terroristici in Europa continuerà a essere perpetrata da soggetti singoli. In più, le linee di demarcazione tra diversi estremismi – jihadista, di estrema sinistra, di estrema destra e altri – saranno via via più sfocate.
Rispetto agli attori solitari con problemi di salute mentale c’è una ulteriore distinzione da fare, secondo Ardavan Khoshnood, professore associato di medicina d’emergenza all’Università svedese di Lund e criminologo I disturbi mentali possono “non renderti più incline al terrorismo, ma più incline a radicalizzarti: è così importante che ci concentriamo sulla nozione di radicalizzazione e come deradicalizzare”, sostiene Khoshnood.
“Le ricerche più recenti hanno portato a una prima distinzione fondamentale tra i cosiddetti ‘lupi solitari’ e i terroristi che agiscono in gruppo. Qualunque sia l’orientamento ideologico, tra i terroristi solitari c’è una incidenza di problemi di salute mentale maggiore rispetto alla popolazione generale”.
Esiste nelle nostre società una vulnerabilità cui prestare attenzione soprattutto nei giovani uomini, che rispetto ad altre fasce di popolazione presentano una più spiccata attitudine a forme di delinquenza e crimine, come spiega anche la criminologa Corner. “Aiutarli – dice – quando non sono ancora pienamente adulti, mentre stanno cercando il loro posto nel mondo, può prevenire le radicalizzazioni”. Aumentare la nostra conoscenza del processo di radicalizzazione, al di là del suo segno ideologico, è utile. “Spesso radicalizzarsi è come andare al supermercato quando si ha molta, molta fame: è estremamente probabile che comprerò del cibo spazzatura, ma quale cibo spazzatura comprerò dipenderà da ciò che per primo vedrò sugli scaffali”. La metafora è di Sara Brzuszkiewicz, ricercatrice di Itstime, centro di ricerca in materia di sicurezza e terrorismo dell’Università Cattolica di Milano. “Certe vulnerabilità alla radicalizzazione esistono indipendentemente dall’orientamento, esiste un sostrato comune molto simile se non uguale: come ti radicalizzi dipende dal contesto cui sei esposto, non tanto dai bisogni ma dall’offerta alla tua domanda”, aggiunge Brzuszkiewicz.
La condizione socio-economica può essere un fattore di vulnerabilità, ma non è detto che lo sia. Gli esempi di terroristi con alti livelli di istruzione o con buone condizioni economiche non mancano. Lo stesso Mohamed Atta era un ingegnere, anche un bravo ingegnere. Inoltre, la condizione sociale svantaggiata può essere un fattore di vulnerabilità anche quando non è reale, bensì percepita, relativa rispetto a qualcun altro, causando risentimento. Con le ideologie che tendono a diventare sfumate e permeabili, come segnalava l’Europol e come può accadere soprattutto nei casi in cui la radicalizzazione avviene online, un campo di ricerca che sta accrescendo la sua importanza è proprio quello della grievance violence, la violenza generata dal risentimento. Il motivo che conduce a un atto estremo di violenza – un attentato terroristico, una sparatoria di massa, o violenze perpetrate da un celibe involontario, un così detto “incel” – è lo stesso, cambia solo l’azione.
Cosa fare allora per prevenire? Rafforzare le politiche statali per la salute mentale è una strada che ha senso percorrere. Rientrerebbe tra le misure di prevenzione soft, che puntano a prevenire la radicalizzazione con l’educazione, la comunicazione e fornendo un quadro narrativo diverso da quello estremista, e che si distinguono dalle misure dette hard, come gli arresti, le espulsioni, il congelamento di beni. Una salute mentale pubblica rafforzata, più efficiente e con più risorse, può portare tra i suoi benefici anche una forma di prevenzione non solo verso la radicalizzazione ma anche per la violenza di genere e altri crimini d’odio. Brzuszkiewicz mi citava la buona gestione dei traumi come un fattore positivo nel contrasto alla radicalizzazione, proprio perché i traumi – reali o percepiti – a livello individuale o di comunità possono scatenare in alcune persone una reazione estremista.

Ma bisogna fare attenzione a non confondere ciò che può fare un professionista della salute mentale e ciò che può fare un professionista della sicurezza: spesso, sono gli stessi psichiatri, psicologi, educatori a ribadire che il loro è un mestiere di aiuto e non di controllo sociale. E poi, non è detto che i soggetti che potrebbero radicalizzarsi e compiere atti terroristici siano individuabili. “Stai pescando in un’acqua dove magari c’è un pesce, però il mare è enorme”, dice Pantucci. Quello che più spesso accade nella realtà è che se gli apparati di sicurezza di un paese hanno due persone da tenere d’occhio ma i mezzi solo per sorvegliarne uno, è probabile che una storia di gravi problemi mentali possa far propendere per la sorveglianza di chi l’ha vissuta.
Rafforzare le politiche per la salute mentale pubblica porta vantaggi di per sé anche se può mitigare solo uno dei tanti possibili fattori che contribuiscono alla creazione di un terrorista. Alcuni paesi, come la Danimarca, hanno sviluppato dei modelli di prevenzione che includono l’aspetto psicologico della radicalizzazione. Non è il caso dell’Italia, storicamente più ferrata nelle forme hard di prevenzione e contrasto. Da dove partire? Brzuszkiewicz insiste sul bisogno di dialogo tra le diverse parti della società coinvolte.
Non esistono strumenti o approcci che vadano bene per ogni contesto. Un punto di partenza, seppure imperfetto, secondo la ricercatrice può essere dotare operatori in prima linea, come gli educatori oppure chi lavora nelle carceri, di check-list ragionate per gli indicatori di radicalizzazione. Si tratta di elenchi puntati che chiedono di fare caso ad atteggiamenti come l’interruzione dei rapporti con i familiari o cambiamenti dell’aspetto estetico, come il passaggio a un abbigliamento religioso. Facendo attenzione, però, a non rendere stigmatizzanti i singoli elementi e tenendo conto della complessità di ogni situazione. “Le checklist degli indicatori di radicalizzazione sono rigide per loro natura, e quindi a volte lasciano il tempo che trovano, però rappresentano un inizio”, commenta Brzuszkiewicz.
Brzuszkiewicz è una dei pochi ricercatori occidentali ad aver visitato, nel 2017, il Correction and Rehabilitation Center, allora noto ancora come Mohammed bin Nayef Center for Counseling and Care, la struttura saudita di riabilitazione e deradicalizzazione voluta quasi vent’anni fa dallo stesso principe saudita bin Nayef (ad oggi rimosso dal potere e lui stesso detenuto). Qui è stato mandato Al-Qahtani dopo Guantanamo. È un centro adiacente alle prigioni di Hair, vicino Riyad, nel quale gli ospiti – che hanno commesso crimini collegati al terrorismo – ricevono un trattamento complesso e che include diversi aspetti, da quello religioso, con la possibilità di colloquiare con degli imam, a quello delle cure per la salute mentale. Se vi è capitato di sentirne parlare, potreste aver sentito dire che si tratta di una rehab di lusso per terroristi. Secondo Brzuszkiewicz è una definizione fuorviante. Sebbene i sauditi abbiano svolto un fraintendibile lavoro d’immagine, mostrando agli occasionali visitatori esterni amenità come piscine e persino un piccolo studio d’incisione, non va sottovalutato il fatto che la deradicalizzazione in un contesto diverso da quello occidentale in certi casi potrebbe essere più efficace. Tuttavia, la ricercatrice sottolinea anche “l’ossessione onnipresente in questo programma sulla appartenenza nazionale” e, soprattutto, il rischio di una normalizzazione del terrorismo. È fuorviante considerare la violenza estremista un disturbo curabile, il terrorismo una voce dei manuali diagnostici per psichiatri. “Come se tu passassi attraverso una sorta di catena di montaggio in cui sei a pezzi e ti rimonto come dico io, ti valuto, e se il prodotto è conforme alle mie aspettative ti rimetto fuori”.
“Oltre al semplicismo nell’approccio al terrorismo, preoccupa quanto ancora stigmatizziamo la salute mentale, associandone i disturbi a comportamenti violenti con un automatismo che ignora le sfumature e i dati, e, ancora, quanto poco ci interessi che sia tutelata per tutti”.
Rischiamo di ridurre tutto all’equazione terrorista uguale pazzo? A ogni nuovo attacco, come quello di pochi giorni fa a Parigi o l’altro avvenuto a Bruxelles il 16 ottobre scorso, quando un cittadino tunisino che si è dichiarato appartenente all’Isis ha ucciso due turisti svedesi, ci aspettiamo il titolo di giornale che riporti qualcosa sulle sue condizioni psicologiche. Ma oltre al semplicismo nell’approccio al terrorismo, preoccupa quanto ancora stigmatizziamo la salute mentale, associandone i disturbi a comportamenti violenti con un automatismo che ignora le sfumature e i dati, e, ancora, quanto poco ci interessi che sia tutelata per tutti. Migliori politiche per la salute mentale per tutti sono necessarie anche quando leggiamo che gran parte degli attentatori degli ultimi anni è perfettamente sana e che allo stesso tempo i terroristi solitari hanno più problemi mentali della media delle persone, sebbene non sappiamo ancora quanto questo incida sulle loro scelte.
Non sapremo mai se Al-Qahtani sarebbe diventato il ventesimo attentatore dell’11 settembre 2001. Nel 2008 l’amministrazione Bush ha deciso di non perseguirlo nel processo che l’avrebbe visto al fianco di Khalid Shaikh Mohammed, reputato la mente degli attentanti, e altri quattro imputati, a causa delle torture subite in carcere. Probabilmente resterà monitorato da diversi apparati di sicurezza per il resto della sua vita.
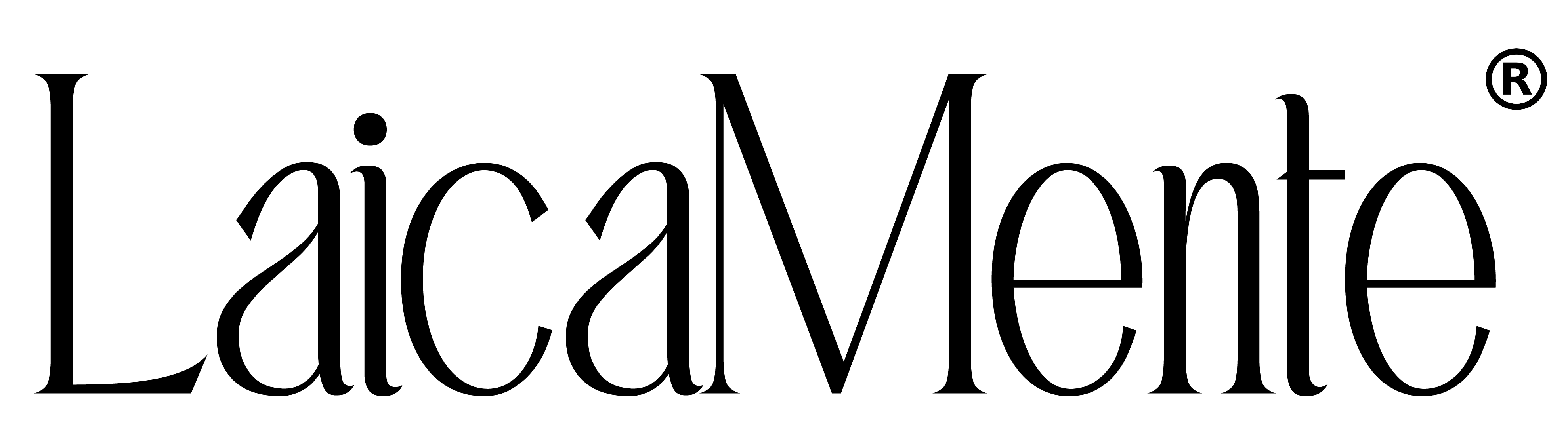

Sorry, the comment form is closed at this time.