
03 Mag L’EDUCAZIONE SESSUALE? CERTO CHE VA FATTA
Tratto da il Mulino, articolo di Enrico zappatore
Si potrebbe cominciare da qui: diventare adolescenti significa soprattutto avere a che fare con un certo numero di circostanze: la formazione di cellule gametiche, un corpo che cambia aspetto in fretta, un considerevole aumento degli ormoni e della libido. Tutte cose che non fanno parte, com’è ovvio, della cassetta degli attrezzi fornita nel corso dei primi dieci anni di vita. Perciò può capitare che i ragazzi si sentano disorientati di fronte alla necessità di ricalibrare il rapporto con sé stessi e con gli altri; e magari che vogliano capirci qualcosa. Solo che non sempre si può o si vuole chiedere ai genitori (soprattutto se l’argomento è il sesso), e dato che spesso la scuola non dà risposte soddisfacenti succede che uno le informazioni se le va a cercare da solo, dove può. Il che, nel 2024, vuol dire Internet; il che, data l’enorme disponibilità di materiale facilmente accessibile, vuol dire pornografia. C’è il problema che il porno è un prodotto pensato per intrattenere e fare soldi, non per educare, e fruirne senza conoscere il linguaggio che usa – cioè senza sapere che niente di quello che accade in un porno ha a che fare con quello che accade nella vita reale – può essere fuorviante. E non importa che si tratti di ragazzi svegli o meno (non importa mai: a quell’età si è sempre facilmente condizionabili). Corollario: è il caso che agli adolescenti si spieghi come si usa un preservativo e come ci si protegge dalla clamidia; ed è il caso che lo si faccia a scuola, in classe.
L’impressione è che, invece, il dibattito sull’educazione sessuale si riduca spesso a una faccenda di blasoni, e cioè che non interessi tanto discutere della questione in sé (dei modi, dei tempi, delle responsabilità), quanto immolarsi a una causa. Più precisamente: certo che a bambini ancora disinteressati al sesso non serve fornire troppe informazioni, certo che è importante non inoculare agli studenti, attraverso patetiche mozioni degli affetti, delle idee su che cosa bisogna pensare del matrimonio, del genere, dell’identità sessuale. Ma il punto è che nessuno, a scuola, pensa davvero che queste cose vadano fatte – dopo anni di corsi di aggiornamento pedagogici e teoria della didattica mal digerita è legittimo pensare che gli insegnanti in gran parte si siano mitridatizzati alle idee che aspirano a migliorare il mondo. Perciò può sembrare curioso che le proposte di legge avanzate negli ultimi trent’anni anni siano cadute nel vuoto. Ma così è.
Le ragioni, mi pare, sono tre. Le elenco provando solo ad abbozzare delle proposte per due di queste. La prima è che c’è una parte dell’opinione pubblica che per motivi culturali, politici e religiosi è contraria all’introduzione dell’educazione sessuale a scuola. La seconda è che un conto è essere favorevoli, un conto è mettersi d’accordo sul programma e sul metodo. La terza è che si teme che i genitori non rinuncerebbero volentieri al proprio primato educativo su un tema che ha connotazioni valoriali così forti.
C’è chi, per motivi culturali, politici e religiosi, è contrario all’introduzione dell’educazione sessuale a scuola. C’è chi, pur favorevole, ha da dire sul programma e sul metodo. E chi non rinuncerebbe volentieri al proprio primato educativo su un tema che ha connotazioni valoriali così forti
Partiamo dalla fine. Se il problema è davvero una presunta riluttanza dei genitori, poco male: un po’ perché può darsi che la realtà sia più sfumata di come ce la immaginiamo; e un po’ perché per comunicare meglio con le famiglie si possono fare delle cose concrete.
Quanto alla realtà e alle sue sfumature, una ricerca del 2023 condotta da diversi ricercatori e ricercatrici dell’Università di Perugia riferisce un dato interessante: sottoposti a un questionario sull’opportunità di introdurre l’educazione sessuale nelle scuole, il 98% dei genitori si è detto favorevole. Certo, è possibile che si tratti di un campione poco rappresentativo (la maggior parte dei partecipanti ha una laurea e risiede nel Centro Nord), ma guardando ai risultati è difficile non pensare che la maggior parte dei genitori vorrebbe almeno avere la possibilità di condividere l’onere con gli insegnanti.
Quanto alla comunicazione con le famiglie, in teoria dovrebbe funzionare così (cito da un pezzo di Jessica Winter pubblicato sul «New Yorker»): «Gli insegnanti dovrebbero fare tre domande ai genitori: c’è qualcosa che dovrei sapere di vostro figlio? C’è qualcosa in particolare che desiderate per vostro figlio quest’anno? E cosa vi preoccupa?». In teoria è semplice. Nella realtà, come capita, non lo è mai. Il problema più grosso è che le infrastrutture e i tempi schiacciati della scuola non sono davvero propizi a instaurare un dialogo del genere. Un insegnante con poche classi, diciamo tre, vede grosso modo sessanta persone al giorno, e progettando le attività didattiche deve tener conto dei progetti, dei desideri, delle curiosità di ciascuno; poi bisogna riunirsi con i colleghi, studiare, partecipare ai corsi di aggiornamento. Come si fa a trovare il tempo di chiamare o incontrare i genitori, di mediare tra i loro progetti e quelli dei figli?
Servirebbero classi più piccole, meno burocrazia, più spazi di confronto. Il fatto che sia difficile, tuttavia, non vuol dire che si debba rinunciare: se il rapporto individuale, genitore per genitore, non è percorribile, si può tentare con il gruppo. Per esempio, all’inizio dell’anno si possono organizzare degli incontri chiamando a scuola delle persone competenti e invitare a partecipare genitori e studenti insieme, magari consegnando a tutti un questionario da compilare alla fine, per capire quale possibilità di apertura al problema esiste. Non bisogna per forza inventare: c’è chi ha lavorato così ottenendo ottimi risultati – penso, per esempio, al progetto EduForIST che, attraverso una serie di sperimentazioni condotte in quattro diverse regioni (Lombardia, Toscana, Puglia e Lazio), ha sviluppato e proposto un modello concreto di attività da portare nelle classi, coinvolgendo famiglie e associazioni del territorio. Semmai bisogna imitare.
Più interessante – e veniamo alla seconda ragione – è la discussione che ruota intorno alla domanda su come bisogna fare educazione sessuale a scuola, e cioè anche chi dovrebbe farla e cosa metterci dentro. Ora, constatato che spendere soldi per realizzare programmi di educazione sessuale abstinence only non è efficace, vale la solita considerazione: il punto non è fornire una tavola di valori a cui attenersi per vivere nella rettitudine ma, più modestamente, produrre degli esseri umani capaci di relazionarsi agli altri, di stare bene con il proprio corpo, di non affrettare risposte, di costruire un progetto di vita. Ma per realizzare questo programma non basta fornire una manciata di informazioni sui metodi contraccettivi o sulle malattie sessualmente trasmissibili: bisogna educare alle emozioni, alla relazione con il proprio corpo e con quello degli altri, al consenso; soprattutto, bisogna demistificare, aiutare i ragazzi a riconoscere bias, stigmi sociali, idee fisse, comportamenti automatici, a distinguere tra una relazione positiva e una venefica. Il che significa anche dedicare del tempo a contenuti di carattere sociale e culturale, come la violenza di genere, le Case di rifugio (che cosa sono, come trovarle) o il post-porno. Non per moralizzare ma per necessità, ossia per fornire agli studenti gli strumenti culturali per fare delle scelte consapevoli e, per esempio, capire che imparare a relazionarsi con il proprio corpo significa anche imparare a riflettere sulla propria identità sessuale – che non è una cosa data, ma un’immagine di sé continuamente negoziata con i modelli sociali. È l’approccio che hanno adottato moltissimi Paesi con un indice di parità di genere migliore del nostro.
Non basta fornire una manciata di informazioni sui metodi contraccettivi o sulle malattie sessualmente trasmissibili: bisogna educare alle emozioni, alla relazione con il proprio corpo e con quello degli altri, al consenso
Affidare tutto agli insegnanti? Anche senza tener conto – ma bisognerebbe – dell’opinione dei ragazzi (il 62% dei quali vorrebbe personale esperto esterno alla scuola), non sembra una buona idea. Un po’ perché è importante che gli insegnanti studino soprattutto la materia su cui si sono laureati e che devono insegnare; e un po’ perché c’è il rischio che succeda come con l’educazione civica, e cioè che non sapendo che cosa fare si brandisca la retorica o ci si affidi, per insicurezza, al manuale – per esempio delegando tutto a un esercizio a piè di pagina che chiede di riflettere sul ruolo della donna. Questo non vuol dire che gli insegnanti non debbano essere coinvolti, perché nessuno meglio di loro conosce le dinamiche e le esigenze della classe, ma solo che è meglio che si occupino di mediare, ossia di prestare attenzione a quei segnali che rivelano moltissimo delle attitudini, delle idee spesso vaghe e confuse dei ragazzi, e di basarsi su queste per progettare delle attività collaborando con realtà esterne alla scuola. Mi pare cioè che agli insegnanti si possa chiedere di fare due cose: di contattare gli enti specializzati che lavorano nel territorio (come associazioni e consultori) per portare persone preparate – meglio se giovani – dentro le aule; e di allacciare l’educazione sessuale all’insegnamento della materia curriculare per offrire una certa continuità con gli interventi esterni, attenti soprattutto a cogliere i bisogni sottostanti alle parole, alle richieste e alle provocazioni degli studenti.
Prima però bisognerebbe dare più soldi alle scuole (gli esperti vanno pagati), e anche formare bene i dirigenti perché sappiano sfruttare al meglio gli spazi forniti dall’autonomia per trovare più fondi. Ma soprattutto bisognerebbe offrire agli insegnanti una formazione seria. E non bastano corsi teorici: bisogna contattare chi ha già lavorato bene e pagarlo per girare le scuole – si può pescare, per esempio, dalla banca dati Dors, che raccoglie progetti, buone pratiche e interventi per la prevenzione e la promozione della salute realizzati soprattutto in scuole piemontesi. Ma ci vuole tempo. Oltre naturalmente alla volontà politica di lavorare in questa direzione.
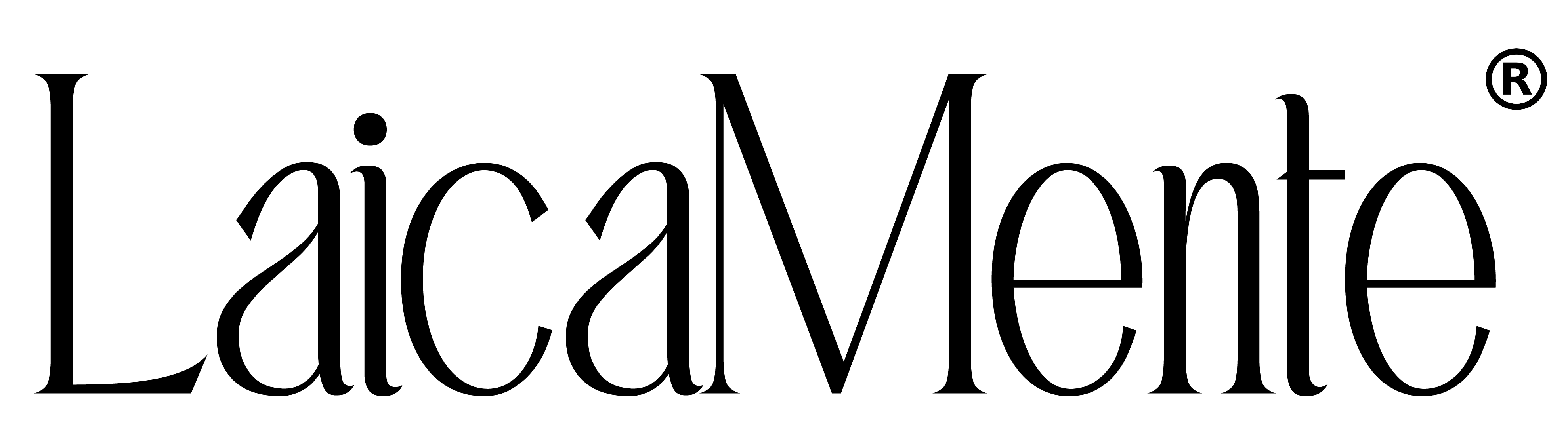

Sorry, the comment form is closed at this time.