
01 Mar Le molestie e l’alibi triste del gap generazionale
Tratto da La Stampa, articolo di Andrea Malaguti
Ci ho pensato a lungo prima di scriverne. Cinquanta-sessantenni che sproloquiano di #Metoo e abusi sono sempre sospetti e, ad andare bene, tendono a fare pasticci, a sbagliare le frasi, a capire male, a prendere strade pericolose, a rifugiarsi – rimpiangendolo – in quello che è stato e che mai più sarà, «a non rendersi conto che» e, in definitiva, a essere crocefissi alle proprie parole, travolti da fraintendimenti che anticipano shitstorm virtuali e reali di dimensioni ciclopiche.
Poi, alla fine di due settimane in cui, qui a Torino, si è parlato senza sosta di molestie e violenze, una collega di grande qualità mi ha raccontato un aneddoto. Che forse non è solo un aneddoto. È andata a intervistare un Importante Signore del mondo culturale italiano. Nel bel mezzo dell’incontro l’Importante Signore le ha detto (testualmente, davanti a terzi) «ma lei è così insistente anche quando fa l’amore?». La collega ha stirato un sorriso di circostanza, ha valutato l’età avanzata dell’interlocutore e il suo prestigioso curriculum.
Poi ha concluso il colloquio sorvolando sulla sgradevole parentesi. Ecco, primo di mille dubbi: «sgradevole» è un’aggettivazione limitativa o, per altri versi, eccessiva? Brava lei, in ogni caso.
Anche se pure su questo si potrebbe discutere. Avrebbe forse dovuto dirgli lì per lì: non si permetta? Far saltare l’incontro? Rinunciare al lavoro? Sarebbe stato troppo o il minimo? Confesso che fatico a rispondere. Ma capisco che di situazioni spiacevoli come questa ce ne sono mille al minuto. In ogni caso, dell’Importante Signore che cosa vogliamo dire?
Lui – manierato, colto, riverito, internazionale, ricco, potente e carismatico – ha fatto ciò a cui è abituato. Lo spiritoso fuori tempo massimo. Il maschio novecentesco. L’ardito e ammiccante uomo da salotti di lusso che regala battute ombelicali umiliando l’ombelico materno che ha consegnato al mondo la sua regale esistenza. Ha detto un’enormità, ma non si è reso conto, ne sono abbastanza certo, prigioniero di un codice spazzato via dal tempo, non dalla sua testa. E, temo, da quella di molti di noi, che sopravvalutiamo il nostro supposto “savoir faire”. Insomma, un maschio abbastanza classico, che fatica a capire il limite e la differenza tra la provocazione ancestrale, il corteggiamento, lo scherzo e la stupidità.
Non c’è reato in quello che ha fatto. Possiamo almeno dire che c’è della volgarità?
Ho parlato di questa storia con una cara e raffinata amica dell’Importante Signore e lei mi ha detto: «Maddai, non fare il bacchettone. Lui è fatto così, non esagerare». Bacchettone ed esagerato. E mi ha ricacciato nella palude del fango lessicale in cui mi sono trovato spesso in questi movimentati giorni torinesi.
Che cos’è dunque accettabile e che cosa no quando ci rivolgiamo agli altri? Chi decide la linea di confine? Come raccontiamo i casi e le storie di esseri umani che finiscono al centro di cronache scivolose e dal profilo opaco? Sta diventando troppo facile puntare il dito contro gli uomini (la risposta è: «a volte, e bisogna fare molta attenzione») o finalmente stiamo rimettendo a posto le cose (la risposta è: «speriamo di sì, anche se con enorme ritardo»)? E, infine, qual è la distanza che corre tra la disinvoltura con cui affrontiamo il tema, le licenze che ci concediamo, e il precipizio di violenza verbale e fisica che travolge da secoli migliaia di donne?
C’è una scala. Non tutto è uguale. Distinguere non è semplice e normalmente, sarà banale dirlo, la sensibilità individuale fa la differenza. Parto dal grado A di “sgradevolezza”, appunto: il presunto caso Viale.
Ricapitolo. Silvio Viale è un sessantaseienne cuneese-torinese conosciuto per molte cose. Ma fondamentalmente tre: è un ex leader di Lotta Continua poi diventato bandiera Radicale, è un ginecologo e, infine, si batte da sempre per il diritto all’aborto. Le ultime due circostanze gli sono valse l’appellativo, auto-attribuitosi e poi dilagato al di là delle sue stesse aspettative, di “medico delle donne”. Motivo per cui molte pazienti vanno da lui certe di sentirsi protette al di là dei doveri professionali. Pare – e dico pare, questo non è un processo – che non sia andata sempre così. Quattro ventenni lo accusano di cose ignobili. Comportamenti inaccettabili, piccole e grandi umiliazioni e frasi molto più che allusive, da suburra portuale ottocentesca. Lui nega. Dice che non ricorda. Che non gli pare. E poi aggiunge una riflessione (nell’intervista alla nostra Irene Famà) che fa cadere le braccia: «Probabilmente c’è un gap generazionale, una volta c’era più apertura mentale, ora non so». Dunque, se queste donne che lo accusano si sono sentite offese è perché – loro – non sono abbastanza aperte e lui sì. Sigh. Non saprei neppure come commentare. Mi pare inutile sottolineare che tra medico e paziente si crea un rapporto di dipendenza-affidamento che dovrebbe definire a priori una forma di delicatezza e di attenzione globale. Ma su una cosa Viale ha ragione: c’è un gap generazionale. Solo che lui lo rivendica come se fosse il deposito etico di un mondo migliore e invece, quella rivendicazione, è la bolla papale sull’incapacità di capire che le organizzazioni sociali – grazie a Dio – si trasformano e crescono.
Aggiungo un’altra ovvietà: chi ha un potere sugli altri è tenuto a una serie di cautele in più.
E qui vengo all’Università di Torino, dove il #MeToo è esploso con un fragore che ha attraversato il Paese scatenando reazioni e dibattiti a catena in molti Atenei, a partire da Roma.
Il confronto – difficile, spigoloso, coraggioso – l’ha sollevato, meritoriamente, la Rete 8 marzo, un gruppo composto da studentesse, ex studentesse e professoresse, stanche del clima pesante, aggressivo e molesto che si respira tra le aule di Palazzo Nuovo e in particolare al dipartimento di filosofia. Dopo avere raccolto una massa di denunce, la Rete le ha portate al rettore. L’Università ha reagito, sono benevolo, con una lentezza disarmante e sospetta. Le accuse di insabbiamento non sono mancate, fino a quando un professore è finito al centro della bufera ed è stato sospeso. Sulle colonne dell’Università sono apparsi manifesti di questo tenore: «Un professore mi ha accarezzato le gambe per complimentarsi con me durante un consiglio di dipartimento». «All’epoca ero dottoranda al dipartimento di filosofia. Ad una conferenza un ricercatore mi disse: come puoi pretendere che la gente ascolti se sei così scosciata?». «Non sapevo a chi rivolgermi e non volevo espormi per non sembrare esagerata, per questo non ho detto nulla sulla molestia verbale subita da un dipendente della biblioteca che ci ha provato con me». Ne cito tre. Ce ne sono cento. Tutte mitomani? Difficile da credere. Ho chiesto a Caterina Stamin, collega poco più che ventenne che si è occupata di questa vicenda, che cosa l’avesse colpita di più nei dialoghi avuti con le studentesse. Mi ha risposto: «Due frasi, che poi sono la stessa. La prima: vabbè, ma si sa. La seconda: è sempre stato così». È ancora accettabile? Le studentesse dell’Università di Torino gridano di no. Stiamo con loro o con la teoria autoassolutoria del “gap generazionale” che piace a Viale mentre esercita il suo ruolo dominante e che sembra il brodo primordiale dell’Importante Signore dei salotti buoni quando restituisce il suo stile veteronarcisista? Anche se capita che la gentilezza venga scambiata per intrusività con una rapidità eccessiva (c’è uno sfasamento di codici comunicativi), forse dovremmo scuoterci tutti dal torpore colpevole che ci avvolge.
Durante la Rivoluzione francese una delle prime azioni dei parigini fu quella di cannoneggiare gli orologi delle cattedrali. Era il loro modo per dire che il tempo, la proprietà del tempo, per dirla meglio, non poteva essere unicamente nella disponibilità del potere politico, ma doveva trasformarsi in un diritto di tutti. Ciascuno doveva essere libero di costruirsi il proprio, spogliandosi dalla schiavitù degli impliciti “contemporanei-eppure-preistorici” delle generazioni precedenti. Bella lezione. Dimenticata.
Ultima riflessione. Sostiene Roland Barthes: «Il privato è quella zona di spazio, e di tempo, in cui io non sono un’immagine, un oggetto». Dobbiamo farci i conti. Il privato degli altri diventa nostro solo quando sono loro a mettercelo a disposizione. Quando si crea condivisione, confidenza, parità di ruolo, familiarità, la struttura emotivo-sentimentale-amicale che definisce e allarga i recinti della relazione. Se manca questo, il rischio di passare alla molestia, e dalla molestia alla violenza, è serio.
Ps. Mentre scrivo sono in treno. È salita una ragazza a Milano. Universitaria anche lei. Studia economia, alla Bocconi mi pare di capire, ne parla animatamente con il ragazzo che le è seduto di fronte. Passa da Federico Caffè a Mario Draghi. Dal progetto Columbia al sogno di Harvard. Si illumina. Poi dice: «Nel mio corso noi ragazze siamo solo in dieci. E il professore quando fa domande guarda le mani alzate e lascia rispondere sempre i maschi».
Istintivamente le credo. Il viaggio è ancora lungo.
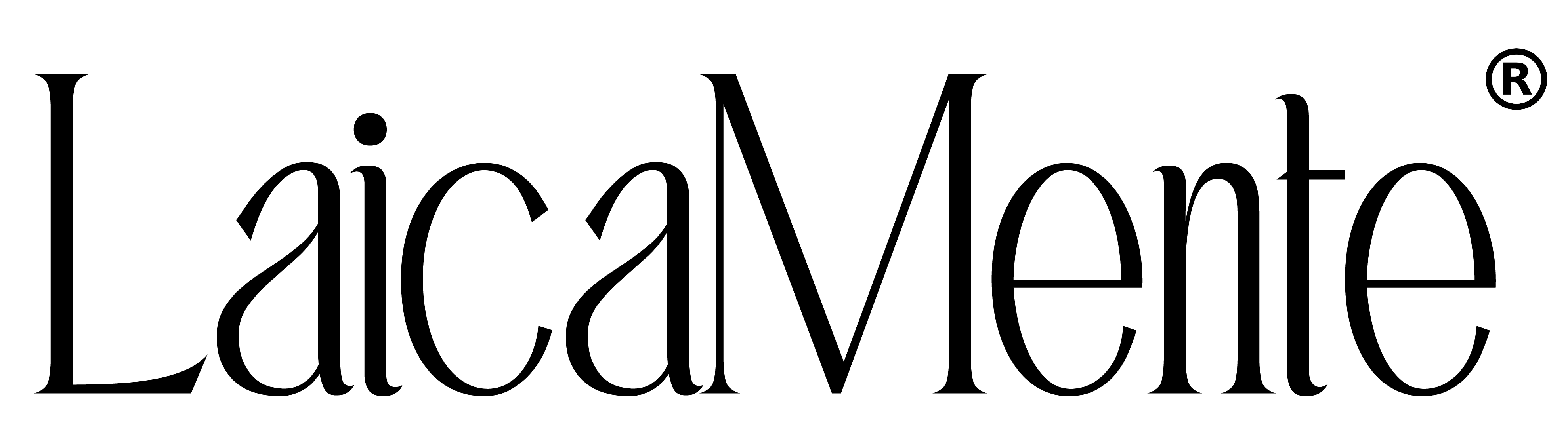

Sorry, the comment form is closed at this time.