
10 Mag L’arte del patriarcato
Tratto da Jacobin Italia, di Anna Clara Basilicò.
A partire da un quadro che raffigura uno stupro ma lo fa passare per atto seduttivo, una riflessione su violenza maschile e storicizzazione dell’oppressione
Questo articolo prendeva forma mentre osservavo una tela di Rubens alla Alte Pinakothek di Monaco di Baviera. In una sala insolitamente ricca di quadri dedicati all’episodio biblico di Susanna – la giovane che, per aver opposto il proprio rifiuto alle offerte sessuali di due vecchi, era stata accusata di adulterio e condannata a morte per lapidazione (Daniele 13) – mi ero poco prima imbattuta nel Suicidio di Lucrezia di Lucas Cranach il Vecchio. Il quadro, avevo scoperto, era stato da poco ripristinato nel suo stato originale.
Un ampio pannello spiegava come, complice il clima bacchettone della contro-riforma, all’inizio del Seicento la nudità di Lucrezia fosse stata censurata con l’aggiunta di un abito. L’intervento aveva inteso restituire all’opera la sua veste originale con un gesto quasi rivoluzionario, che spogliava (letteralmente, in effetti) il corpo della donna dai veli imposti dalla Chiesa. Mi ero allontanata dal pannello piuttosto infastidita da quell’inflazione di fraseologia rivoluzionaria, come la chiamava Antonio Gramsci, capace di attribuire un valore rivoluzionario a processi egualmente patriarcali. Stavo ancora riflettendo sull’omissione cronica della funzione performativa dello sguardo maschile, quando voltandomi alla mia destra mi sono imbattuta nel Ratto delle Leucippidi di Rubens. Tra i numerosi rapimenti dell’antichità, quello delle Leucippidi è in realtà tra i meno famosi, per cui vale la pena riassumere le vicende a beneficio del lettore.
La violenza sessuale come atto poietico
Si narra che regnasse un tempo, sul lembo sudoccidentale del Peloponneso, il mitico Leucippo. Padre di tre giovani donne, il re aveva promesso la mano delle figlie Febe e Ilera ai nipoti Idas e Linceo, figli di suo fratello Afareo. Le fonti raccontano tuttavia che Leucippo avesse segretamente accettato di cedere le giovani donne ai Dioscuri – i gemelli Castore e Polluce – in cambio di ricchezze, e avesse così acconsentito al loro rapimento. «I due figli di Giove traevano dunque, rapite, / di Leucippo le due figliuole», provocando di necessità la reazione di «Ida gagliardo, e Linceo, / promessi e vicini alle nozze» (Teocrito, Idilli 22). Il duello tra i Dioscuri e gli Afaretidi si concluse con la morte di Castore, Idas e Linceo.
L’episodio, come accennavo, non gode di grande fama tra le fonti, ma nei suoi Idilli Teocrito lo sceglie per illustrare la gloria di Castore. A differenza della tradizione precedente, questa era la prima volta in cui lo scontro tra le due coppie di fratelli si svolgeva all’interno di un regolamento di conti dovuto al tradimento di Leucippo. Tanto Pindaro nelle Nemee quanto i Cyntia raccontavano infatti che a muovere Ida e Linceo era stata l’ira per il furto, da parte dei Dioscuri, dei loro buoi. Mogli o buoi, dunque, che nell’economia del racconto assolvono alla medesima funzione mitopoietica.
La sorte delle Leucippidi – è il patronimico a introdurle al lettore – non è nota, ma la tradizione del testo teocriteo (insieme forse ad altri scomparsi nel tempo) ha concorso alla consacrazione di una certa immagine della violenza sessuale all’interno del mondo europeo e occidentale.
Può darsi si rifiuti, e allora i baci
prendili a forza. Forse si opporrà […]
Ma, pur combattendo, vorrà essere vinta.
[…]Chiamala pure violenza: ma questa violenza piace alle donne.
Vorrebbero essere costrette con la forza a concedere ciò che desiderano concedere.
Qualsiasi donna che subisca lo stupro di Venere
Ne gode, e la perversità diventa un dono.
E la donna che, pur potendosi costringere, viene lasciata andare intatta,
Pur fingendo gioia nel viso, sarà triste.
Febe subì la violenza, violenza fu inflitta alla sorella,
Eppure, entrambi gli stupratori furono graditi alle stuprate
(Ovidio, Ars amatoria, 1).
Circa duecentocinquant’anni dopo, Ovidio cristallizzava così l’exemplum delle due sorelle con una formula destinata a fare giurisprudenza: vis grata puellae, la violenza che piace alla donna. L’episodio delle Leucippidi aveva trovato spazio nel primo libro dell’Ars Amatoria – un’opera, ironia della sorte, stesa per insegnare all’uomo comune come conquistare la donna. Non ego divitibus venio praeceptor amandi / … / pauperibus vates ego sum, «Io non vengo maestro d’amore per i ricchi / … / Io sono poeta per i poveri» (Ovidio, Ars amatoria, 2). Ai ricchi bastava elargire doni per ottenere l’amore, mentre i poveri avevano bisogno di altri strumenti. E la coercizione era gratuita.
Quando nel 1618 Rubens decide di trasporre su tela l’episodio ovidiano, lo fa fermando l’attimo in cui i Dioscuri, avendole raggiunte a cavallo, afferrano Febe e Ilera per trascinarle con loro, aiutati da due cupidi che reggono le briglie degli animali. La critica ha suggerito che l’espressione ammiccante del cupido di sinistra stia in realtà informando lo spettatore della finzione di quella ritrosia. A oltre un millennio e mezzo di distanza dal racconto di Ovidio, Rubens riconfermava una visione culturale del ratto che riconosce alla violenza un potere seduttivo. Al di là della scelta del soggetto, quello che però ha colpito la mia attenzione è stata la didascalia esposta, che riporto integralmente in traduzione:
Lo stupro delle figlie di Leucippo, ca. 1618
Il rapimento delle figlie del re ebbe esito fatale dacché Castore e Polluce vennero uccisi durante l’inseguimento. Pur essendo gemelli, erano figli di due padri diversi. Castore era figlio di Tindaro, re di Sparta, e quindi mortale; non era così per Polluce, figlio di Giove. Quando Polluce chiese di non essere separato dal fratello, vennero trasformati entrambi in corpi celesti. Attraverso la complessa composizione che suggerisce una serie di punti di osservazione diversi e la resa sensuale delle texture, Rubens dimostra la superiorità della pittura sulla scultura.
La legenda informa sommariamente delle circostanze della morte dei fratelli e del loro catasterismo. Febe e Ilera vengono presentate come le «figlie del re». Si tace sul loro destino, si magnifica quello dei loro stupratori. La legenda non è stata scritta da Rubens o da un suo contemporaneo, ma da qualche storico dell’arte del ventunesimo secolo che ha avuto il merito di dimostrare in poche righe la continuità della società contemporanea rispetto un’eredità millenaria, che ha normalizzato la violenza di genere relegando la donna (e gli altri segmenti sociali subalterni) al dominio dell’oggetto e dell’irrazionalità. La poesia di Ovidio emergeva all’interno di una società che annoverava tra i propri miti fondativi il ratto delle Sabine e il suicidio d’onore di Lucrezia. Eccolo qui il mito di Roma, la violenza sessuale come atto poietico. E c’è un filo che lega i Dioscuri, Tarquinio, Ovidio, Rubens e l’anonimo compilatore di schede museali.
Il classico come un dogma
Se la filologia mi ha insegnato a riconoscere dietro ogni parola l’inscindibilità di storia letteraria e storia culturale, la storia mi ha insegnato che la fortuna di un’opera informa più sulla società che la tramanda che sul contesto in cui è nata. Se si tengono a mente le due lezioni si può facilmente convenire intorno a quel che Sebastiano Timpanaro nel 1973, nel n. 28 della rivista Belfagor, definiva «il senso della politicità della cultura e dei suoi condizionamenti economico-sociali» e avvertire di conseguenza «l’esigenza di una cultura ‘militante’ e legata alla prassi». Si tratta di un approccio che permette di scorgere con chiarezza quel fil rouge e di rintracciarne la genealogia sepolta sotto un complesso di fattori, tra cui un certo problematico approccio alla pedagogia dei classici – o, per meglio dire, all’idea che i classici siano prodotti intrinsecamente pedagogici – e la mancanza di una teoria critica egemone.
Nel passato più recente, la cristallizzazione del concetto di cultura da un lato e la sua demonizzazione dall’altro hanno contribuito a rendere sempre più difficile una lettura «paratestuale» dei classici. Agitati come spauracchio elitistico, vengono rifiutati da un certo sentimento antintellettualistico – di cui populismi e sovranismi si nutrono. Ad arginare questo processo interviene di contro un intellettualismo fine a sé stesso, impegnato in una difesa a oltranza di quei monumenta. Ciascuna delle due tendenze alimenta l’altra, rinforzando l’idea che con i classici non sia necessario un dialogo – non sia possibile, in effetti. Il testo di Ovidio, la tela di Rubens, sono oggetti immobili e immobilizzati all’interno di un divenire storico che si fa sempre più forsennato e perde la capacità di interloquirci. Nel migliore dei casi, l’opera di Ovidio viene ignorata, nel peggiore idolatrata (ma ammetto di non essere affatto sicura che l’ordine degli aggettivi sia corretto). E quel che resta è una percentuale desolante di persone che ritiene che no non significa sempre no. Quod iuvat, invitae saepe dedisse volunt, «Quel che davvero desiderano è concedere contro voglia, lor malgrado, riluttanti – invitae –, quel che piace loro», con la cesura del pentametro che imporrebbe, dopo ìnvitàe, una pausa, per meglio assaporare quella riluttanza ipocrita.
Se chi ritiene che una donna abbia la possibilità di rifiutare un rapporto sessuale se davvero lo vuole un giorno si imbattesse nei distici di Ovidio, probabilmente ne trarrebbe la riconferma della fondatezza delle proprie opinioni, così come Ovidio la poteva trarre da Erodoto. «I barbari ritengono che rapire le donne sia azione da delinquenti, ma che preoccuparsi di vendicare delitti del genere sia pensiero da dissennati: l’unico atteggiamento degno di un saggio è non tenere il minimo conto di donne rapite, perché è evidente che non le si potrebbe rapire se non fossero consenzienti» (Erodoto, Storie, 1). Riconferma che rischia esattamente di sfuggire a chi, troppo impegnato nella salvaguardia di un passato immobilizzato, vive il classico come un dogma e scrive di Castore e Polluce invece che di Febe e Ilera.
Le origini del maschilismo
Esiste un modo per scongiurare entrambi questi rischi? Nel numero 2/2024 di MicroMega compaiono due contributi di Eva Cantarella e Giuliana Sgrena, entrambi dedicati alle radici storiche del patriarcato. Le due autrici sono giunte a conclusioni molto diverse. O meglio, sono partite da premesse molto diverse. Cantarella apre il suo saggio stabilendo che è «nella Grecia classica che per la prima volta le donne sono sistematicamente escluse dallo spazio pubblico». Sgrena, poco dopo, dimostra invece il ruolo decisivo delle religioni abramitiche nella costruzione di un impianto ideologico che legittima l’oppressione della donna partendo dall’assunto che «strutture sociali patriarcali si possono rintracciare in Europa già fra il 7000 e il 3500 a.C.». Vorrei poter dire che il secondo saggio costituisce una risposta al primo, ma non è così. Lo stato di arretratezza della discussione intorno al modello patriarcale è tale da non aver individuato in cinquemila, tremila o duemila anni una sede per portarla avanti.
Nel descrivere la cultura siciliana, Sciascia osservava come si svolgesse tra i suoi protagonisti una specie di dialogo tra sordi, e la stessa sordità mi pare di ravvedere nel dialogo intorno al patriarcato, con una significativa, decisiva, differenza: che non si tratta di sordità individualista, ma indotta e imposta. Gli studi di Cantarella e Sgrena – e di centinaia di altre donne – sono in realtà cruciali per la cultura militante: la questione dell’origine del patriarcato non è problema trascurabile. Lo è forse l’origine del fascismo? Capire come nasce il patriarcato consente di verificare quali siano state le condizioni che ne hanno favorito l’emergere, quale sia stato il processo adattivo, che struttura sociale ne sia derivata e quali segmenti sociali ne abbiano beneficiato. Permette di osservarne resilienze e accelerazioni nel continuum storico della longue durée. Di studiarne la relazione con le strutture dell’economia politica, l’interazione con le categorie della storia del pensiero. In ottica costituente, rende possibile ricercare la lunga storia di resistenze al dominio patriarcale, di studiarne le vittorie e le circostanze della sconfitta. Queste sono tutte operazioni preliminari tanto alla decostruzione e allo smantellamento quanto alla sustanziazione di un processo creativo che, dati i caratteri di rottura, non può che definirsi rivoluzionario.
Da questo punto di vista, la storicizzazione rischia di porsi in aperto contrasto con qualsiasi istanza trasformativa contribuendo alla cristallizzazione del passato. In tal modo, si sottrae la storia al piano della contesa e la si consegna nelle mani di chi da quella storia è uscito vincitore. È in virtù di questo processo che qualche mese fa un filosofo poteva annunciare a mezzo stampa – tra non pochi sospiri di sollievo – che il patriarcato era morto cinquecento anni or sono. Il mancato riconoscimento da parte di Massimo Cacciari dell’immanenza del modello patriarcale non costituisce un elemento di novità. Nominalismi simili vengono agitati dai detrattori delle argomentazioni intorno alla «cultura dello stupro», che rimuovono la storicità di quel processo sociale di intimidazione con cui l’uomo mantiene la donna in uno stato di paura e subalternità. Eppure la donna – intesa come categoria storico-sociale – contiene in potenza l’autonomia necessaria al raggiungimento dell’egemonia: è esattamente per questo che ricostruirne la storia è gesto politico.
Sebbene Gramsci rifiutasse il paragone tra dominio di classe e «maschilismo», le riflessioni che applicava alle classi subalterne sono altrettanto valide per le donne. Studiarne la storia, risalirne le tracce, tracciarne un inventario significa garantire loro quell’unità storica che finora solo la classe dirigente è stata in grado raggiungere. Un’unità che ha assunto la forma dello Stato, motivo per cui la storia ha coinciso per secoli con la storia degli Stati. Una forma dalle origini antichissime, che risalgono alle prime città-stato della Mesopotamia, la cui nascita sarebbe da mettere in relazione proprio con uno stravolgimento del ruolo della donna all’interno della società, sopraffatta dai vecchi sacerdoti. Quando Erodoto descrive l’inizio della Storia mostra indecisione sulle circostanze dell’inizio dell’inimicizia tra Greci, Persiani e Fenici, ma tutte le versioni che riporta convengono su di un punto: il rapimento di una donna. Che fosse Io, Europa, Medea o Elena, il corpo delle donne era divenuto terreno di conquista, era stato colonizzato. È mettendo in relazione l’oppressione delle donne, la nascita delle città-stato e le prime forme di accumulazione che possiamo interpretare il capitalismo e lo Stato-nazione come la più avanzata forma di patriarcato, e possiamo finalmente cogliere l’importanza di un’altra storia, di altri archivi, capaci di incidere a tal punto sulla cultura da non concedere più spazio ai Dioscuri di ogni tempo, ma di raccontare la storia delle Leucippidi finalmente libere dal loro giogo.
*Anna Clara Basilicò è una dottoranda dell’Università di Padova e Ca’ Foscari. Si occupa di storia del carcere della prima età moderna, con particolare attenzione alle carceri del Sant’Uffizio.
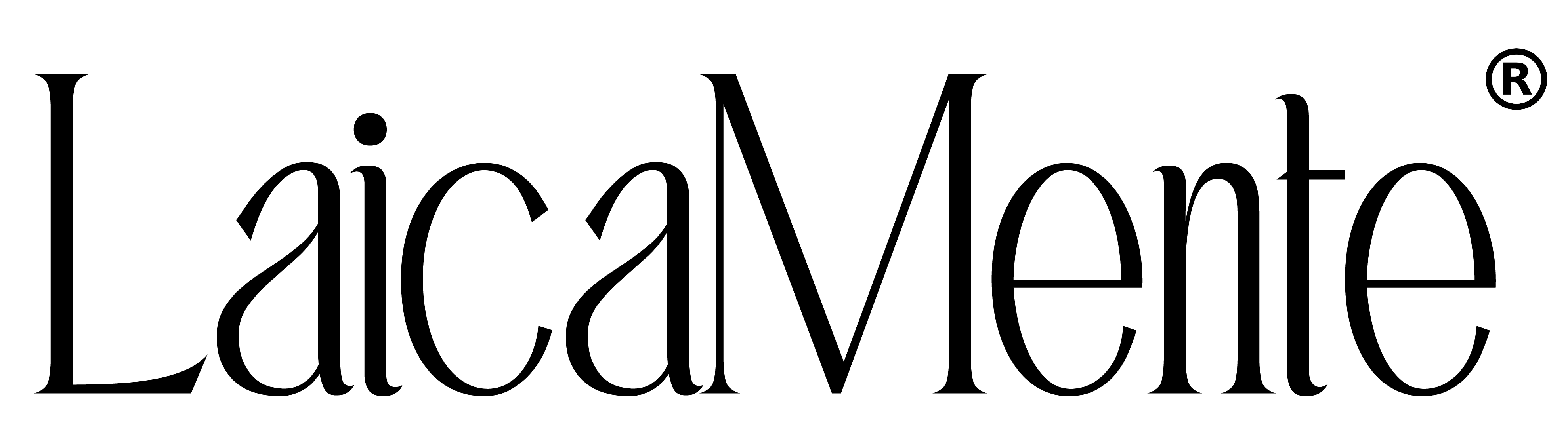

Sorry, the comment form is closed at this time.